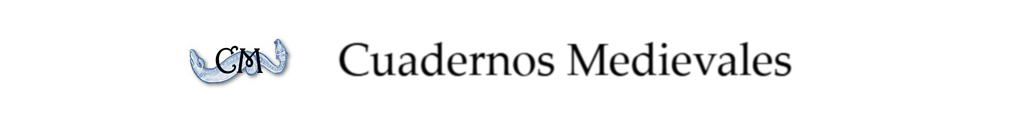DONNE AL LAVORO NEL MEDIOEVO: LA SITUAZIONE ITALIANA
WOMEN AT WORK IN THE MIDDLE AGES: THE ITALIAN SITUATION
Maria Paola Zanoboni
Università degli Studi di Milano
mpzanoboni@gmail.com
Fecha de recepción: 14/07/2023
Fecha de aprobación: 14/08/2023
Resumen
La opinión tradicional consideraba que el trabajo femenino en la época medieval era un trabajo poco remunerado, restringido únicamente a los sectores textil y alimentario y, generalmente, dependiente del trabajo del marido, al margen de los gremios.
Por el contrario, un corpus considerable de pruebas resultantes de investigaciones sobre documentos italianos y europeos del siglo xiii hasta finales del siglo xv, demuestra que durante las centurias bajomedievales en varios países europeos el trabajo femenino se empleaba en casi todos los campos de actividad, incluidos los edificios, las minas, el procesamiento de la sal. Los salarios de las mujeres eran proporcionales a su capacidad real y no estaban condicionados por el sexo.
En muchos casos, las mujeres conseguían mantener a toda la familia (o saldar las deudas del marido) con su propio trabajo. Además, algunas mujeres vendían sus vestidos y joyas para obtener capital con el que fundar una empresa. Las señoras de la nobleza se dedicaban a trabajos muy diversos, como la organización de talleres de bordado, la gestión de minas y saneamientos, el establecimiento de lecherías o la dirección de hostales.
Las mujeres mostraban una notable habilidad en la organización del trabajo a pesar de la enorme variedad de sus tareas y preferían estar fuera de los gremios; por otro lado, las corporaciones de oficios toleraban este tipo de trabajo en negro, pero intentaban obligar a las mujeres a estar registradas cuando se necesitaba un control especial.
El aprendizaje femenino era a menudo informal, pero en determinados casos se desplazaba cuando las trabajadoras necesitaban demostrar su capacidad en algunos trabajos, como la fabricación de materias primas preciosas. En otros casos, los gremios obligaban a las mujeres a estipular un contrato de aprendizaje por escrito, sobre todo en los ámbitos de la salud pública, por ejemplo, para amasar pan.
Palabras clave
Mujeres – Trabajo - Italia medieval - Gremios artesanales - Mujeres empresarias - Emprendimiento femenino - Mercado del crédito
Abstract
The traditional opinion considered female labour in medieval age low paid work restricted to textile and feeding fields only and generally dependent on husband’s work, outside of guilds.
On the contrary, a considerable body of evidence resulting from researches on Italian and European documents of XIII century up to the end of 15th century, shows that during 13th, 14th and 15th centuries in several European countries female work was employed in almost all fields of activity, including buildings, mines, salt processing. Women’s wages were proportional to their real capacity and were not conditioned by gender.
In many cases women succeeded in supporting the whole family (or discharging their husband’s debts) by their own work. Moreover, some women sold their dresses and jewels to obtain capitals in order to establish a firm. Noblewomen were involved in very different jobs as embroidery workshops organization, mines and reclamation management, dairy establishment, hotel management.
Women showed a remarkable ability in work organization in spite of the enormous variety of their tasks and they preferred to be outside of guilds; on the other hand, guilds tolerated this type of black work but tried to compel women to be registered when a special control was needed.
Female apprenticeship was often informal but in particular cases it was displayed when workers needed to demonstrate their ability in some jobs such as precious raw materials manufacture. In other cases, guilds obliged women to stipulate a written apprenticeship contract, particularly in public health fields, for example to knead bread.
Keywords
Women – Labor - Medieval Italy - Craft Guilds - Business women - Women’s Entrepreneuership – Credits – Market
Oltre gli stereotipi
Dagli studi più recenti sul lavoro femminile medievale emerge un quadro completamente diverso rispetto agli stereotipi tradizionali: non donne chiuse in casa a svolgere mansioni domestiche, o filatura, tessitura e cucito, ma attivissime in tutti i settori (compresi i più pesanti, come l’edilizia o il lavoro in miniera), e a tutti i livelli, dalla manovalanza all’imprenditoria, riuscendo spesso a mantenersi da sole e persino ad aiutare familiari in difficoltà. La rigorosa analisi di fonti fino ad ora poco sfruttate (atti notarili, fonti giudiziarie, statuti corporativi, fonti fiscali) e il raffronto tra le ricerche specifiche su contesti geografici anche molto lontani tra loro, hanno messo in evidenza realtà e linee di comportamento comuni a tutte le donne d’Europa (secc.xiii-inizio xvi), ben diverse da quelle che la tradizionale storiografia sull’argomento continua da decenni a ripetere.[1]
L’analisi dei singoli microcosmi consente di percepire, nella concretezza e nella peculiarità delle situazioni, il modo di pensare e di agire delle donne medievali. Tra le caratteristiche comuni a vasti ambiti cronologici e geografici emerge in primo luogo il fortissimo spirito di corpo e la capacità organizzativa che portavano le donne, un po’ dovunque in Italia e in Europa, a integrarsi perfettamente nella vita economica, sociale e politica delle loro città, arrivando talvolta a trattare direttamente con le autorità municipali, ottenendone il consenso. E questo anche in assenza di associazioni professionali, alle quali le lavoratrici facevano di tutto per rimanere estranee, costituendo ampi nuclei di manodopera fluttuante e sommersa che rappresentava il cardine del sistema corporativo. Si trattava cioè di lavoro nero estremamente flessibile, che per le sue capacità di adattarsi alle esigenze del mercato era spesso favorito sia dagli impremditori, sia dalle istituzioni cittadine. Di reti di relazioni e di poteri informali, alle quali si affiancavano processi, spesso altrettanto informali, di trasmissione dei saperi.[2]
Un aspetto che emerge in modo macroscopico in molti statuti corporativi è la tendenza delle associazioni professionali ad estendere —quando necessario a tutela della collettività e a prevenire gli illeciti— il proprio controllo su determinate attività femminili. Questo avveniva mediante l’obbligo di giuramento all’arte e/o di iscrizione alla matricola; mediante l’imposizione delle tasse corporative o del versamento di una cauzione; mediante la richiesta di redazione scritta del contratto di apprendistato. Indipendentemente dall’area geografica e dall’arco cronologico, il principio era sempre lo stesso: prevenire le conseguenze negative che in certi settori potevano nascere da un mancato controllo sul lavoro femminile. Un controllo che si esercitava cercando di assoggettare le donne alla corporazione, e non espellendole. La qualità del rapporto esistente tra donne e corporazioni è ben sintetizzata in una rubrica degli statuti degli oliandoli e pizzicagnoli di Firenze che enunciava in volgare (1318) e in latino (1345) il medesimo concetto, ovvero “di costrignere le femine di questa arte a rispondere d’ogni cosa” (debiti contratti per l’esercizio dell’attività, qualità dell’olio, rispetto dei termini di consegna)[3].
Per parte loro, le donne facevano di tutto per rimanere nell’ombra, e anche la redazione scritta dei contratti di apprendistato avveniva solo quando sussisteva un loro preciso interesse a stipularli, dovuto di solito alla necessità di un riconoscimento scritto dei saperi acquisiti. Per il resto, donne e corporazioni si tolleravano reciprocamente in una sorta di tacito accordo fatto di legami e vincoli informali, che, pur trapelando soltanto a tratti dalla documentazione, costituivano il nerbo del sistema corporativo.[4]
Alle donne, cioè, entrare a far parte di una corporazione non interessava affatto. Ne percepivano infatti il ruolo costrittivo e limitativo di tutte quelle attività che tendevano a svolgere dovunque capitasse, autonomamente su commissione di un mercante, o come piccole imprenditrici coordinando un universo femminile sommerso, nella massima libertà e senza vincoli né obblighi di alcun tipo. Le corporazioni si limitavano a prendere atto dell’esistenza di “laborator vel laboratrix, tam maschulini, quam feminini generis”, intervenendo solo in caso di illegalità (come i furti di materie prime), o di concorrenza diretta all’universo maschile, o di tutela e controllo qualitativo degli articoli contenenti materie prime preziose o dei prodotti annonari (per le panificatrici in particolare); oppure ancora in ambito sanitario.[5] In questi casi i vertici corporativi, lungi dall’escludere l’elemento femminile, agivano proprio in senso contrario, cercando di far emergere le attività “sommerse” e di sottoporle al controllo dell’arte.
Il riconoscimento corporativo e l’ufficializzazione dell’apprendistato mediante la stipulazione di un contratto scritto, non rappresentavano insomma per l’universo femminile il traguardo positivo di un percorso ascendente di mobilità sociale, ma piuttosto un’imposizione —da parte dell’associazione professionale o dell’autorità pubblica, o anche della necessità contingente di un riconoscimento formalizzato— , a cui si cercava di assoggettare le donne (non senza una loro strenua opposizione) in particolari circostanze, connesse con la tutela del prodotto o della collettività.[6]
Se in alcuni statuti l’obbligo per le donne di iscriversi, effettuare un preciso e formalizzato periodo di apprendistato, rispettare le norme igieniche e versare le tasse corporative è ben esplicitato (es. per i panificatori di Firenze, Cortona, Ascoli Piceno, Milano), in altri, pur sussistendo, viene appena accennato da espressioni come “così masgio como femina”, “pueri et puellae”, “discipulus vel discipula”, o anche soltanto “illo vel illa”, “qui, vel que”, per cui soltanto un capillare esame del testo parola per parola può svelare la presenza femminile. Presenza che talora doveva essere sottintesa, come trapela da almeno due compilazioni statutarie (statuti cittadini di Ascoli Piceno, 1377 e statuti della federazione delle arti di Piacenza, 1346), dove si afferma che tutte le norme espresse al maschile si intendevano riferite ad entrambi i sessi, affermazione che apre uno squarcio notevole sulle potenzialità della giurisdizione corporativa nei confronti delle donne e sulla loro celata presenza.[7]
Aspetto non trascurabile che emerge da alcuni dettati statutari (cristallai veneziani, 1284; tessitori di lana piacentini, 1450 circa; speziali piacentini, 1457), denotando la considerazione che veniva tribuita alle lavoratrici, era poi l’obbligo di partecipare alle loro esequie, alla pari con gli uomini.[8]
Altri tratti comuni all’Italia come a tutta l’Europa erano la non marginalità del lavoro femminile, talvolta in grado di garantire la sopravvivenza a colei che lo esercitava e alla sua famiglia (come alcuni mariti riconoscevano apertamente)[9], e la sua capillare diffusione in tutti i settori e ad ogni livello, con la massiccia presenza anche di ben organizzati nuclei imprenditoriali.
Un’altra questione importante che emerge dagli studi più recenti è il fatto che la maggiore o minore entità dei salari femminili non era dovuta alla differenza di genere, ma il loro ammontare veniva determinato da una pluralità di fattori (età, perizia tecnica, conoscenza diretta della capacità lavorativa del soggetto) di cui il genere costituiva soltanto uno degli elementi, e non il fondamentale.[10]
Non si trattava sempre e soltanto di attività complementari a quelle dei mariti, ma di occupazioni i cui proventi erano spesso in grado di far fronte autonomamente a situazioni di necessità, o anche di ruoli imprenditoriali ad alto livello e completamente autonomi, talvolta ereditati, in altri casi intrapresi in prima persona.[11]
Il comparto tessile
Il settore tessile costituiva nella Penisola l’ambito precipuo verso cui convergevano le attività muliebri, anche se non era il solo. A Piacenza tra il xii e il xiii secolo, le donne ricoprivano un ruolo importante in questo comparto, tanto da essere menzionate in continuazione con parità di diritti rispetto agli uomini negli statuti dei mercanti della città: potevano istruire apprendisti, commerciare lino e tele, erogare e contrarre mutui.[12]
A Bergamo verso la metà del ‘300 esistevano operaie nel settore laniero e imprenditrici in quello del lino. Nel 1349 una di loro aveva costituito una piccola società con una collaboratrice, alla quale lasciò poi per testamento tutti i tessuti che aveva in magazzino, gli utensili per esercitare l’attività e l’usufrutto del locale che costituiva il suo atelier.[13]
Nella Firenze di fine Trecento il numero di donne impiegate nella tessitura della lana era nettamente superiore a quello degli uomini, situazione che cambiò solo verso la metà del secolo XV quando i tessitori tedeschi subentrarono alla manodopera femminile.[14] Piccole aziende a conduzione familiare e con un certo numero di discepoli erano gestite da marito e moglie che si alternavano al telaio, o da due donne socie tra loro.[15] Numerosi contratti di apprendistato in quest’ambito riguardavano piccole apprendiste venute dal contado, remunerate solo con vitto e alloggio.[16]
A Roma nel ‘500 —in un settore, quello laniero, in cui l’organizzazione produttiva era di solito in mano agli uomini— , esistevano delle imprenditrici. Una delibera dell’arte della lana della Città Eterna (1530) lascia trapelare l’esistenza, accanto ai lanaioli (patroni), di lanaiole (patronae) che facevano parte della corporazione e coordinavano il processo produttivo inviando la materia prima alle filatrici e facendola ritirare presso di loro.[17]
Dal ‘300 in poi, nella maggior parte delle città italiane ed europee,[18] esistevano in particolare tre settori esclusivamente femminili, caratterizzati da notevoli ed autonome capacità organizzative: le fasi preliminari alla filatura serica (trattura, binatura e incannatura); la filatura dell’oro; la confezione di veli e cuffie/acconciature di seta e di cotone. In quest’ultimo caso si trattava di articoli destinati alle donne e che richiedevano un gusto prettamente femminile nell’ideazione, per cui praticamente in tutta Europa veniva lasciata loro la gestione dell’intero ciclo produttivo ed organizzativo, dalla realizzazione dei modelli, alla tessitura e alla commercializzazione, compreso l’investimento di capitale necessario ad avviare l’attività.[19] Le aziende femminili per la produzione di veli e cuffie, infatti, si autofinanziavano mediante la vendita di abiti o monili più o meno preziosi.[20]
Gli altri due ambiti (fasi preliminari alla filatura serica e filatura dell’oro) vedevano invece in genere le donne come segmento produttivo (anche se spesso autonomamente organizzato in veri e propri piccoli laboratori artigiani), del processo di lavorazione facente capo all’imprenditore, con l’eccezione di Venezia dove, nel ‘400, esistevano “mercantesse pubbliche” che controllavano tutto il ciclo di lavorazione dell’oro filato.[21]
Era proprio in questi tre settori che meglio si esplicava il lavoro femminile.
La seta: imprenditoria, manovalanza, furti di materie prime
Nella maggior parte dei centri urbani della Penisola (a Lucca , Bologna e Genova fin dal ‘200, dal ‘300 a Venezia, e dal ‘400 a Firenze e a Milano), la manifattura serica rappresentò per molti secoli il caposaldo dell’economia cittadina, in grado di dare lavoro a migliaia di persone, e risorsa fondamentale di sussistenza per i ceti più umili, tanto che i governi locali ne favorirono con ogni mezzo la fioritura.
A Genova[22] già nel ‘200 la filatura dell’oro (come molte altre attività), era di esclusiva pertinenza femminile: i numerosi contratti di apprendistato che la documentano dimostrano che le maestre appartenevano ai più diversi ceti sociali, dalle mogli degli artigiani (fabbricanti di scudi, battiloro) a quelle dei notai, e che a volte entravano in società tra di loro, facendosi finanziare da un mercante col quale dividevano al 50% i guadagni (1248), mentre in altri casi ancora lavoravano a cottimo per un imprenditore (1250)[23]. Numerose donne entravano in affari stipulando contratti di commenda, sia per investire in modo redditizio la dote, sia anche per promuovere all’estero gli articoli che realizzavano. Appare infatti di notevolissima importanza il fatto che, proprio attraverso la commenda, molte di loro cercassero nuovi mercati per collocare al meglio i loro prodotti: rocchetti di oro filato, affidati a più riprese a soci che li esportavano in Sicilia e in Sardegna (1226), in Siria, a Cipro, in Turchia e ad Alessandria d’Egitto (1237)[24], pezze di fustagno per Acri e per la Corsica (1224), capi di vestiario da vendere in Sicilia, tovaglioli da smeciare a Napoli (1226), vino per Tunisi (1222): una vasta gamma di articoli, dunque, che le donne genovesi realizzavano in proprio, facendosi al tempo stesso promotrici del prodotto sul mercato internazionale. Fin dal ‘200, insomma, un buon numero di esponenti della parte femminile della città non si limitava ad attività domestiche, agricole o artigianali, ma interveniva direttamente nelle contrattazioni commerciali, cercando di collocare la merce nel modo migliore.[25]
Ugualmente a Lucca, sempre nel xiii secolo, erano presenti numerose tessitrici di drappi serici leggeri, che compivano un rigoroso apprendistato per lunghi periodi di tempo (fino a 10 anni), ricevendo talvolta come compenso, oltre all’insegnamento del mestiere, anche il telaio e gli strumenti necessari all’attività. Qualcuna di loro raggiungeva persino la qualifica di “publica mercatrix”. Anche in seguito le donne della città dovettero essere molto attive in questo settore, se una società fondata nel 1332 aveva alle proprie dipendenze ben 101 tessitrici che realizzavano zendadi e taffetà.[26]
Anche nella Firenze quattrocentesca, la trattura e l’orditura della seta, e la filatura dell’oro, erano di esclusiva competenza femminile, come la contabilità di battiloro e setaioli documenta ampiamente.[27]
A Venezia nel ‘300 le donne erano attive in gran numero nella trattura e nell’incannatura, nella produzione dei tessuti serici leggeri, solitamente in posizione subalterna a qualche maestro, e, ancora una volta, nella filatura dell’oro.[28] Tra la fine del ‘400 e la fine del ‘500 esistevano nella città lagunare piccole aziende domestiche dedite all’incannatura della seta, del tutto autonome dal mondo maschile, e nelle quali si costituivano gerarchie con compiti diversi a seconda dell’età: le donne più anziane, non più in grado di lavorare in prima persona, ma ricche di esperienza ed autorità, si dedicavano all’aspetto organizzativo, mentre quelle in età matura insegnavano l’attività alle più giovani (oltre a praticarla in prima persona). Questo universo lavorativo interamente femminile non era scevro da forti tensioni, dovute al fatto che le maestre che godevano di miglior fama si facevano affidare dai setaioli ingenti quantità di materia prima che ridistribuivano ad amiche e conoscenti disoccupate, rimanendo però responsabili in prima persona della seta ricevuta dal mercante. Si trattava insomma di un mondo fortemente indipendente, organizzato, gerarchico, e non privo di forti conflittualità interne.[29]
Le ricerche più recenti hanno messo in luce anche il ruolo delle donne veneziane nel settore dell’oro filato: dotate di propri capitali, fra ‘300 e ‘400 controllavano come “mercantesse pubbliche” ufficialmente riconosciute dal governo della Serenissima (che imponeva loro di iscriversi all’albo e di versare una cauzione), tutto il ciclo di lavorazione, dall’acquisto della foglia (e talvolta dalla sua realizzazione) alla vendita.[30] Soprattutto da quando, nel 1420, il Senato veneziano aveva emanato una serie di provvedimenti a favore dell’arte e del lavoro femminile che ne costituiva il fulcro, liberalizzando il commercio dell’oro filato, molte donne di ogni ceto sociale avevano investito nel settore, dando vita ad aziende di varie dimensioni da loro gestite e coordinate, autonomamente o in società con altre donne, o con mercanti o battiloro.[31] All’attività prendevano parte anche numerose esponenti del patriziato veneziano che conducevano gli affari in prima persona, come socie di capitale e d’opera contemporaneamente, talvolta accanto a banchieri/finanziatori di cui erano parenti. Nei primi decenni del xv secolo, la mercantessa Pasqua Zantani si occupava di tutto il ciclo produttivo: aveva una bottega per la produzione della foglia d’oro in cui lavoravano alcuni uomini alle sue dipendenze; era in contatto con un banchiere veneziano ed uno di Norimberga, da cui si riforniva dei materiali preziosi; distribuiva la foglia alle filatrici e vendeva il filo d’oro. Aveva poi rapporti commerciali con numerose altre donne che svolgevano la stessa attività.[32]
Accanto alle nobildonne non mancavano nella città lagunare esponenti del ceto medio-basso che, pur prive di risorse, riuscivano ad emergere, come Lucia “ab auro” che nel 1395 si era fatta un nome esercitando l’arte dell’oro filato, di cui controllava l’intero ciclo produttivo, fino alla vendita. Sebbene, dopo molti anni di attività, continuasse a dipendere da numerosi finanziatori, gestiva comunque una piccola azienda, con l’aiuto di una schiava e della figlia, divenute in seguito sue socie nell’esercizio. L’attività era ancora fiorente nei primi anni del ‘400 sotto la guida della figlia di Lucia.[33]
Anche a Vicenza e a Verona, durante tutto il ‘500, donne di varia estrazione sociale –tra le quali molte nobili-, partecipavano attivamente a società (spesso a loro intestate e che portavano il loro nome) per la produzione e il commercio su scala internazionale di tessuti di lana o seta che esportavano nei principali centri dell’economia europea (Lione, Anversa, Francoforte, Londra). Queste imprenditrici non si limitavano a fornire i capitali, ma controllavano personalmente la contabilità e sovrintendevano le scelte organizzative e gestionali, intervenendo nella contrattazione per l’acquisto delle materie prime e la vendita del prodotto finito.[34]
Ancora a Vicenza un processo per furto dibattuto nel 1527 fornisce abbondanti notizie su un’imprenditrice attivamente impegnata nella produzione e nella commercializzazione di veli in seta, lino e cotone, e di fazzoletti in seta; la sua operosità nel settore —dichiaravano concordemente tutti i presenti— le consentiva di ottenere grandi guadagni.[35]
A Milano dove, a differenza che in altre città italiane, l’arte della seta era giunta soltanto negli anni ‘40 del ‘400,[36] erano di competenza delle maestre le fasi preliminari alla filatura,[37] che veniva poi completata dai filatori col mulino da seta, apparecchiatura a trazione animale o a energia idraulica, mediante la quale il filo, preparato su appositi rocchetti, veniva sottoposto a vari tipi di torsione che lo rendevano adatto ad essere tessuto. Le donne, alle quali la figura imprenditoriale del filatore consegnava in prima battuta la materia prima, svolgevano la trattura; l’incannatura, e la binatura.[38]
L’attività era praticata a domicilio e in dipendenza dalle commesse del filatore/imprenditore, che a sua volta dipendeva da un mercante proprietario della materia prima, il setaiolo. Questo favoriva abbondantemente i furti da parte delle maestre che non avevano remore a far sparire in continuazione modesti quantitativi di seta da utilizzare per piccoli business in proprio. Le appropriazioni indebite delle donne a scapito dei filatori (ai quali i mercanti accollavano poi la responsabilità degli ammanchi), avevano raggiunto a Milano negli ultimi decenni del ‘400 e all’inizio del ‘500 un’entità tale, che le maestre vennero fatte oggetto di specifici capitoli in ben due degli statuti con cui i filatori tentarono di ottenere dal Duca una corporazione autonoma.[39]
Nel 1479 e poi ancora nel 1511 i filatori di seta chiesero di comminare aspre sanzioni alle maestre colte a rubare la materia prima.[40] Nel 1479 venne ribadito che le donne avrebbero dovuto restituire direttamente ai mercanti, anziché ai filatori, la seta ricevuta da trarre, in modo che questi ultimi non potessero essere ritenuti responsabili dai mercanti dei furti commessi dalle maestre.[41]
Nel 1511 una nuova proposta statutaria molto più articolata prevedeva che anche le donne venissero sottoposte alla giurisdizione corporativa, e fossero giudicate per direttissima dai maggiorenti dell’arte come tutti gli altri 'maestri, lavoratori e garzoni'.[42] Alle trattrici e binatrici era poi dedicata una serie di norme volte a scongiurare i furti o a recuperare il maltolto. Il nome della maestra che per due volte avesse trattenuto della seta sarebbe stato segnato su una lista nera e nessun filatore avrebbe più dovuto darle lavoro, pena la perdita della facoltà di ricorrere in giudizio in caso di eventuale furto. Una volta iniziato un lavoro per un filatore o un mercante, le maestre erano tenute a portarlo a termine prima di iniziarne un altro. Infine veniva sancito il diritto dei filatori di perquisire le case delle maestre per recuperare la seta rubata.[43]
Una situazione identica si stava verificando esattamente negli stessi anni nel dominio genovese dove i furti delle filatrici di seta avevano raggiunto un livello tale che proprio nel 1511 venne organizzata da alcuni setaioli insieme ai consoli della corporazione una spedizione contro le filatrici della Val Polcevera per recuperare il maltolto. Il tentativo fallì miseramente, e anzi i poveretti vennero malmenati e insultati, uscendone malconci.[44] Sicchè, qualche anno dopo, la corporazione ottenne dal Comune di poter istituire un carcere apposito per le donne.[45]
A Venezia nello stesso periodo le botteghe dei merciai e delle merciaie erano veri e propri centri di ricettazione della seta, rubata soprattutto dalle binatrici e incannatrici, come si lamentava in una denuncia del 1535 contro un merciaio che acquistava sistematicamente (a prezzi bassissimi) dalle maestre e dai garzoni la materia prima da loro sottratta. Alcune donne erano spinte al furto da necessità di sopravvivenza, altre lo esercitavano in maniera professionale.[46]
A fronte di tale stato di cose, riscontrabile nei principali centri serici della Penisola, accanto alle maestre che lavoravano in proprio a domicilio come dipendenti dirette del filatore, andarono costituendosi anche a Milano (sul modello veneziano)[47] piccole aziende coordinate da donne di estrazione sociale più elevata e a volte parenti dei filatori, che distribuivano la seta tra le lavoratrici a domicilio, esercitando su di loro un controllo più stretto. Appare significativa in proposito la vicenda della vedova di un filatore che nel 1495 stipulò un accordo con un parente del marito: gli avrebbe messo a disposizione il magazzino, una camera e la bottega con quattro mulini da seta e vari utensili che vi si trovavano, perché il congiunto potesse esercitarvi l’arte di persona, con l’ausilio di lavoranti che sarebbero stati remunerati da entrambe le parti. La vedova avrebbe invece reclutato e coordinato le maestre incannatrici e binatrici. Guadagni e perdite sarebbero stati divisi al 50% tra il filatore e la vedova. Sebbene la donna non fosse tenuta a rimborsare al parente l’eventuale diminuzione di peso della seta dovuto al calo naturale, era però responsabile per metà degli eventuali furti commessi dalle lavoratrici che da lei dipendevano.[48]
Parallelamente andava accentuandosi ovunque il controllo corporativo sulle lavoratrici della seta. Difronte a una tale diffusione dei furti di materie prime si innescò infatti contemporaneamente in molte città italiane ed europee, tra gli ultimi due decenni del quattrocento e i primi del cinquecento, il tentativo di un capillare controllo del lavoro nero (maschile e femminile), con particolare attenzione alle donne, che erano le più coinvolte. In questo panorama si collocano i citati provvedimenti degli statuti dei filatori milanesi (1479 e 1511), quelli dei merciai della capitale sforzesca (1497), la spedizione genovese contro le filatrici della Val Polcevera (1511), le denunce contro i merciai veneziani che si rifornivano con la seta rubata (1535). Sempre agli anni ’80 del ‘400 risale il tentativo della corporazione dei tessitori di seta di Basilea di imporre l’iscrizione anche alle produttrici di veli (che rifiutarono), tentativo che innescò una controversia conclusasi a favore delle donne, sostenute da quei mercanti (collusi col governo cittadino) che ne sfruttavano il lavoro nero.[49] Al 1482, infine, risalgono gli statuti dei tessitori di seta di Lucca, città dove l’attività delle tessitrici era diffusissima fin dal ‘200. Il dettato statutario, imposto dai mercanti ai tessitori, e motivato esplicitamente dalla volontà di contrastare i furti, che ricadevano soprattutto sui mercanti (statuti, rubrica 6), sanciva nel modo più capillare l’assoluto controllo corporativo su tutti gli iscritti all’arte —al difuori della quale era tassativamente proibito lavorare— e per una parte notevole si trattava di donne. Un controllo che si voleva esercitare a tutti i livelli: maestri e maestre, capo-maestri e capo.maestre, lavoranti e “lavorantesse”, apprendisti e apprendiste, garzoni e “garzone”. L’intento coercitivo della corporazione si spingeva al punto di richiedere un costante monitoraggio con precisi elenchi nominativi di tutti i dipendenti di ciascun tessitore (uomini e donne), apprendisti/e, lavoranti e “lavorantesse”. Anche il numero dei telai utilizzati da ciascun maestro o maestra doveva essere dichiarato e costantemente aggiornato, e ugualmente registrate e marchiate le tele in lavorazione. Per i non iscritti all’arte vigeva la proibizione assoluta di tenere telai, mentre agli iscritti/e era severamente vietato svolgere altre attività in cui si utilizzasse la seta.[50]
Le filatrici d’oro
Collegata al comparto serico, di cui costituiva una branca importante, la filatura dell'oro, rappresentava un altro settore di impiego della manodopera femminile di grande importanza, documentato in particolare a Milano, a Genova, a Firenze, e a Venezia (oltre che a Colonia e nelle città tedesche).
Le filatrici ottenevano le commissioni dai “battiloro”, specializzati nella realizzazione di lamine di metallo così sottili da poter essere avvolte su filo di lino o di seta. Questi artigiani giocavano un ruolo di prim’ordine nella creazione dei tessuti preziosi (i drappi auroserici), la cui domanda da parte delle corti rinascimentali durante il xv secolo era cresciuta vertiginosamente, sia nel settore del l’abbigliamento, sia in quello dell’arredamento: tende, cortine da letto, coperte ricamate in oro, velluti, damaschi e broccati intessuti di seta e fili in metallo prezioso. Le foglie da filare rappresentavano il risultato finale di una serie di battiture che dal pane di metallo giungevano a una lamina sottilissima che manodopera femminile, organizzata autonomamente in laboratori esterni, avvolgeva poi su filo di seta o di lino. In questo modo la manifattura era organizzata dovunque è documentata: a Genova già nel ‘200, a Venezia, Colonia, Montpellier dal ‘300, a Firenze e a Milano nel ‘400,[51] a Lione nel ‘500.[52]
Due tipi di materiali venivano utilizzati dai battiloro: metalli preziosi oppure oricalco, cioè ottone. Per evitare frodi ogni bottega era specializzata in una sola di tali produzioni, e sempre per scoraggiare le falsificazioni gli statuti degli orefici vietavano severamente di avvolgere su filo di seta i materiali non pregiati. A Milano in particolare,[53] accanto alla domanda di tessuti preziosi realizzati con filo d’oro e d’argento, se ne era formata una parallela, di imitazioni povere fatte di oro falso, ottenuto appunto dalla foglia di ottone avvolta intorno ad un’anima in lino o in cotone, anziché in seta.[54]
Un elenco di ben 198 filatrici che lavoravano per una sola bottega dimostra quanto l’attività fosse diffusa nella capitale del Ducato Sforzesco nel secondo ‘400. Non si trattava di semplici lavoratrici a domicilio ma di maestre autonome che gestivano veri e propri piccoli laboratori e assumevano contemporaneamente parecchie apprendiste con contratti del tutto simili a quelli maschili, e dotate anzi di una specializzazione ancora maggiore: buona parte dei documenti rimasti riguarda infatti la formazione di maestre. Nella capitale del ducato sforzesco questo è uno dei pochi settori in cui esisteva in modo consistente un apprendistato ufficiale in tutto simile a quello maschile, ed anzi ancora più specializzato. Trattandosi di un’arte nuova necessitava, anche a causa del valore delle materie prime, di un rigoroso ciclo di insegnamento, spesso effettuato da maestre tedesche.[55] A Colonia, del resto, fin dal ‘300 le filatrici d’oro avevano l’obbligo di iscriversi alla corporazione dei battiloro da cui dipendevano, e che ne avrebbe regolamentata l’attività, tutelando la qualità del prodotto, e scongiurando le frodi.[56]
Il lavoro femminile in questo settore costituiva dunque un segmento di primaria importanza di un’attività che avrebbe raggiunto in brevissimo tempo proporzioni enormi. Negli ultimi due decenni del XV secolo, a Milano, e fin dalla prima metà del ‘400 a Firenze,[57] il ceto dei grandi mercanti/banchieri si era letteralmente buttato su questa nuova produzione intuendone gli sviluppi futuri, riconvertendo le proprie attività da settori affini e contendendosi con compensi altissimi i battiloro stranieri perché insegnassero l’arte ai propri figli. Alla fine del ‘400 la produzione del filo d’oro e dei drappi auroserici aveva ormai raggiunto un giro d’affari di proporzioni enormi con la stipulazione di società per centinaia di migliaia di lire, finalizzate nella maggior parte dei casi alle forniture di corte. All’inizio del ‘500 banca e finanza, manifattura accentrata e lavorazione a domicilio, trovavano il loro fulcro, incentrato proprio sulla produzione e sul commercio dei drappi auroserici, nelle fiere di Lione. Intorno a questo prodotto ruotavano tutti gli altri traffici, e in primo luogo il commercio del denaro, i trasferimenti di capitali, le transazioni finanziarie, in mano prevalentemente a mercanti-banchieri fiorentini e milanesi.[58] Nel 1548, e poi ancora nel 1570, era divenuta —affermavano i mercanti milanesi— il principale e più redditizio comparto produttivo della città, dando lavoro ad oltre 20.000 persone, tra battiloro, filatori di seta, filatrici d’oro, tintori e garzoni, ed alimentando esportazioni in Francia, Spagna, Inghilterra, Fiandre, Ungheria, e in “ogni altra regione del mondo”[59].
Fin dagli ’70 del ‘400 i tessuti di seta trapunti d’oro dominavano la moda della corte sforzesca. Il cronista Bernardino Corio, descrivendo il corteo con cui il duca di Milano Galeazzo Maria Sforza si era recato a Firenze nel 1471 in visita a Lorenzo de’ Medici, affermava che a memoria d’uomo non si ricordava un apparato più sontuoso. I consiglieri e i feudatari che lo accompagnavano erano vestiti con abiti tagliati all’ultima moda di panno intessuto d’oro e d’argento, mentre cortigiani adorni di velluto e altri finissimi drappi di seta, camerieri con divise splendenti di ricami, staffieri dalle giubbe di panno d’argento o di seta, cuochi con livree di velluto o raso componevano il seguito. Tessuti di seta e staffe dorate, selle trapunte di ricami d’oro e d’argento, coperte di damasco bianco e bruno recanti le insegne ducali ornavano i 2000 cavalli e i 200 muli con cui il duca attraversò l’Appennino. Le finanze dello stato e quelle dei mercanti (verso i quali lo Sforza aveva accumulato debiti su debiti) risentirono non poco di tutta questa magnificenza: il solo corteo era costato 200.000 ducati, cioè circa 800.000 lire dell’epoca, somma enorme se si pensa che con 14.000 lire si poteva acquistare un castello di medie dimensioni.[60]
Veli e cuffie di seta e oro o di cotone
Il settore dei veli (di cotone o di seta) è tra i più rappresentativi delle modalità organizzative e imprenditoriali femminili: tra il xiv e l’inizio del xvi secolo, dalle valli aretine a Bologna, Milano, Venezia, Verona, Padova, Vicenza, Basilea, fino a Maiorca, a Barcellona, a Porto, questa produzione era interamente in mano alle donne, raggruppate in piccole organizzazioni verticistiche facenti capo a vere e proprie imprenditrici che si autofinanziavano con la propria dote. Autonome o in società tra di loro, tenevano i contatti con i mercanti e distribuivano il lavoro a domicilio alle tessitrici, spesso coadiuvate da allieve.[61]
A Milano la realizzazione dei veli in cotone (affiancati da quelli in seta negli ultimi decenni del xv secolo)[62], era appannaggio di organizzazioni imprenditoriali complertamente femminili. Lo testimonia una società, costituita tra due donne nel 1481, in cui le contraenti ricoprivano un ruolo economico ed imprenditoriale notevolissimo per l’epoca. La socia di capitale, vedova, disponeva di una somma (100 lire) senz'altro cospicua per una donna di ceto medio basso, da immobilizzare per un periodo di due anni, fatto che denota una grande sicurezza sulla bontà dell’investimento e sulle possibilità di espansione del settore. La socia d’opera era invece al vertice non solo dell'intero ciclo produttivo, dall'acquisto della materia prima alla sua distribuzione alle lavoratrici a domicilio, all'ideazione degli articoli da confezionare, ma anche della commercializzazione del prodotto, senza l'intervento nè la mediazione di alcun mercante. Gli utili sarebbero stati divisi in parti uguali tra le due contraenti. Il contratto societario lascia intuire tutto un substrato di attività femminili a domicilio sommerse, coordinate e finanziate ancora da donne, un mondo che aveva la sua base in un brulicare di occupazioni svolte dovunque capitasse (in casa propria o di committenti vari, o in un angolo della bottega del marito), spesso con l'aiuto di figlie ed apprendiste assunte con accordi orali che una fitta rete di conoscenze, amicizie e relazioni di quartiere procurava. Un mondo che emerge solo qua e là dai documenti in tutta l’esuberanza ed il pulsare della vita.[63]
In altri casi erano singole imprenditrici a gestire interamente il processo produttivo, con propri capitali, ottenuti dalla vendita di modesti gioielli o di abiti di un certo valore. E questo ruolo di imprenditrice autonoma rivestì negli anni ’90 del ‘400 la moglie di un importante ricamatore attivo presso la corte sforzesca. Nel suo testamento egli dichiarava a tutela della consorte Orsina, che gli erano pervenute 125 lire ricavate dalla vendita di cinture, verette, anelli ed altri gioielli a lei appartenenti, somma che in seguito era passata direttamente in mano alla moglie che l’aveva utilizzata nel commercio e nella produzione dei veli da lei esercitata per proprio conto. Orsina dunque agiva come imprenditrice nella più completa autonomia, sia per quanto concerne il capitale, sia per quel che riguarda la gestione dell’attività che si intuisce fatta al tempo stesso di commercio e di produzione, probabilmente coordinando altre velettaie che lavoravano a domicilio.[64] Dato che le cuffie in velo erano spesso ornate da importanti ricami, per Orsina doveva essere più facile procurarsi una clientela importante grazie all’attività del marito, ricamatore di corte, anche se la committenza dei duchi e del loro entourage poteva rivelarsi molto pericolosa.[65] Altro particolare notevole: Orsina si autofinanziava con la propria dote, pratica comune alle donne di tutti i ceti sociali.[66]
La vicenda imprenditoriale di Orsina ebbe un seguito inaspettato. Uno dei suoi sette figli, G. Giacomo da Sesto, dopo aver esercitato per alcuni anni l’arte del ricamo come il padre, trovandosi in cattive acque decise di ripiegare sul lavoro della madre, cosa che gli consentiva un impiego di capitali enormemente inferiore, mettendolo al tempo stesso al riparo dai rischi di insolvenza dei committenti connesso con le forniture di corte. L’inventario della sua bottega, stilato il 16 maggio 1506, pochi giorni dopo la sua improvvisa e prematura scomparsa, indica chiaramente che aveva trasformato l’attività del ricamo in quella della produzione di cuffie, veli e gorgiere (colletti elaboratissimi in seta, trapunti d’oro o ricamati), inserendosi in un comparto produttivo completamente dominato dalle donne. Nella sua bottega faceva tessere soltanto i prodotti più preziosi, in oro tirato (novità merceologica importante in quegli anni a Milano), o faceva ricamare gli articoli più elaborati, di cui curava personalmente i disegni (custoditi, protetti da un sacchetto, in una credenza dell’atelier). Faceva tessere invece a domicilio (sicuramente da manodopera femminile), veli, cuffie e gorgiere di vario tipo e modello in seta o in cotone. Coordinava probabilmente questo secondo comparto la moglie Maddalena (figlia di un setaiolo) che doveva aver imparato l’attività dalla suocera Orsina, ereditandone la clientela e i contatti, e che cercava però di rimanere nell’ombra per non essere costretta ad iscriversi alla corporazione dei merciai, come era stato decretato anche per le donne solo pochi anni prima (1497). Con la morte di G.Giacomo la bottega sarebbe passata all’unica figlioletta, la piccola Margherita di 8/10 anni, tornando così in mani completamente femminili.[67]
La struttura produttiva milanese per la realizzazione dei veli era quindi in parte diversa da quella che caratterizzava le filatrici d’oro della città, necessariamente dipendenti dall’imprenditore per la materia prima, e dedite al tempo stesso all’istruzione di nuove allieve in un’arte di recente introduzione a Milano. Questi motivi, insieme alla necessità di uno stretto controllo sulle lavoranti, portavano a costituire per la filatura dell’oro veri e propri laboratori artigiani composti da una maestra che teneva i contatti col mercante, dal quale riceveva la preziosa materia prima di cui era responsabile, distribuendola alle allieve presenti nel suo atelier sotto il suo stretto controllo.[68]
Nella produzione dei veli, di seta o cotone che fossero, prevaleva invece il modello dell’imprenditrice autonoma o in società con un’altra donna, che affidava a domicilio il lavoro ad altre maestre, che potevano anch’esse avere delle apprendiste.[69] La differenza determinante era rappresentata dal fatto che in questo caso le donne erano proprietarie delle materie prime e dei capitali.
Anche a Venezia, tra ‘400 e ‘500, la tessitura dei veli era completamente in mano alle donne, a volte alle dipendenze di velettai imprenditori che gestivano e coordinavano l’attività; in altri casi nella veste di imprenditrici autonome che affidavano il lavoro a domicilio ad altre donne, o di tessitrici che lavoravano in proprio, vendendo poi il prodotto nei mercati. Alcune di loro godevano di un tale riconoscimento ad ogni livello, da poter imprimere il proprio marchio sui veli che uscivano dai loro ateliers.[70]
Botteghe seriche a compartecipazione societaria femminile a Milano
Mentre nella prima metà del ’400 le donne dell’aristocrazia milanese non esitavano a investire ingenti capitali in società per la lavorazione della lana,[71] nella seconda metà del secolo il boom della manifattura serica e della filatura dell’oro offrì al lavoro femminile meneghino nuove opportunità con vari gradi e a vari livelli di partecipazione.
Il ricchissimo inventario degli oggetti che la proprietaria di una bottega per la vendita di fettucce, cuffie, passamanerie lasciò alla sua morte dimostra quanto le imprenditrici milanesi fossero introdotte in questo settore. Quantitativi di seta colorata di ogni tipo, filo e frange d’oro e d’argento, argento semilavorato, ‘bindelli’, corde di seta, frange ed ornamenti di ogni genere, pezze di velluto, damasco e broccato, bottoni d’oro, d’argento e di seta, borse in broccato d’oro e d’argento o in velluto, tasche in tessuto d’arazzo, un telaio per ricamare, dei fusi, un banco e sedici casse da bottega, oltre a padelle, pentole, suppellettili varie, e a qualche abito, facevano parte del ricchissimo elenco. La presenza poi di un vestito da uomo e di due abiti femminili da lutto, nonché di due culle (di cui una lavorata con la testera dipinta), e di varie piccole lenzuola e coperte, lasciano intuire che si trattava di una vedova, forse ancora giovane, con più di un figlio.[72]
Per una bottega dello stesso tipo (anche se i prodotti erano in parte cambiati a causa del mutare della moda) una vedova costituì una società nel 1532, col figlio del funzionario ducale adibito all’approvvigionamento di oggetti preziosi, e con un socio d’opera, conferendo in merci i due terzi del capitale. Si trattava in questo caso soltanto di un’attività commerciale, come denunciano apertamente le clausole. I prodotti di base rimanevano gli stessi della precedente bottega (corde e tessuti di seta, ‘bindelli’, passamanerie e guarnizioni, borse e guanti), ma vi si aggiungeva una gran quantità di penne e pennacchi colorati per elmetti e armature, cappelli di ogni genere (di velluto o di feltro), ‘scuffiotti’ di tutti i tipi (di seta, di velluto, a maglia, ‘da villano’), e persino un ‘papagorgio’ dorato. Tra le borse compaiono quelle di Lione e quelle ‘alla tedesca’. Novità assoluta anche alcuni bicchieri di cristallo smaltati o lavorati in oro, e una ghirlanda profumata.[73]
Altre vedove mandavano avanti le aziende dei mariti come imprenditrici e come mercantesse, investendo nel settore serico capitali ingentissimi. Tra loro Mattea Vaprio, sorella del pittore di corte Costantino e vedova dell’importante mercante auroserico e fornitore dei duchi Damiano de Valle, che nel febbraio del 1485 assunse un apprendista al quale avrebbe insegnato di persona il lavoro (probabilmente a livello amministrativo e gestionale), mentre nell’agosto dello stesso anno, durante una terribile pestilenza, ottenne un rimborso di ben 3.111 lire (su un capitale investito di 2.850) per una società con un altro importante mercante, appena sciolta forse proprio a causa dell’epidemia.[74]
Altre ancora agivano come finanziatrici di grossissime società commerciali, affidando somme ingentissime agli imprenditori auroserici perché le facessero fruttare, in un periodo in cui la manifattura dei drappi di seta intessuti di oro e di argento aveva raggiunto l’apice nella capitale del Ducato Sforzesco, assicurando guadagni stratosferici agli investitori. Nel 1490 la vedova Lucrezia Landriani consegnò al mercante e ricamatore di corte Nicolò da Gerenzano ben 7.136 lire da impiegare nel commercio di filo d’oro e tessuti preziosi, dividendo a metà con lui guadagni e perdite. Il sodalizio commerciale produsse sicuramente notevoli risultati, dal momento che il termine iniziale di 3 anni venne prorogato fino all’ottobre del 1501.[75]
Le farmaciste
Altra attività intrapresa a livello manageriale dalle donne nel ‘400 era quella farmaceutica,[76] completamente in linea con la spiccata propensione per questo settore che il genere femminile aveva in tutta Europa. A Firenze, ad esempio tra xv e xvi secolo, l’arte era così importante e remunerativa che molti conventi femminili traevano le risorse necessarie al proprio sostentamento dall’attività di farmaciste svolta dalle suore. Le botteghe all’interno dei monasteri, che vendevano medicamenti, cosmetici e dolcetti, erano punti di aggregazione e di scambio di conoscenze per il mondo femminile della città di Dante. La provenienza sociale di molte religiose contribuiva ad attirare nelle farmacie donne altolocate, con ricadute positive sui contatti esterni e sull’economia del convento.[77] In Germania (sec. xv-xvi) invece, erano le matrone laiche di famiglie benestanti ad essere particolarmente abili nell’uso delle erbe, con cui confezionavano medicamenti che regalavano alle bisognose. In Francia, proprio per la loro particolare propensione ad apprendere l’uso delle erbe e delle sostanze medicamentose, le donne erano tenute lontane dall’attività, di cui le corporazioni maschili degli speziali detenevano il monopolio. Le mogli dei farmacisti perciò, pur ammesse ai banchetti della corporazione, venivano allontanate quando si parlava di erbe e ricette medicinali.[78]
Anche Milano si inserisce pienamente in questa tradizione di interessi femminili di cui fu esponente illustre Caterina Sforza (1463-1509), figlia illegittima del duca Galeazzo Maria e di Lucrezia Landriani, che sposò nel 1484 Girolamo Riario , nipote del papa Sisto IV, divenendo signora di Imola e di Forlì, e fu celebrata dal Machiavelli per le sue gesta eroiche.[79] Occupatasi a lungo di erboristeria, medicina, cosmesi e alchimia, Caterina, che per tutta la vita si era dedicata a sperimentazioni in questo campo, arricchite da continui scambi di corrispondenza con medici, speziali, nobildonne e fattucchiere, ci ha lasciato un trattato (gli Experimenti), in cui raccoglie 471 ricette per combattere le malattie o per conservare la bellezza. Da questa importantissima raccolta emergono intuizioni formidabili che vennero alla ribalta nel mondo scientifico solo molti secoli più tardi, quali l’uso del cloroformio come anestetico. Numerose anche le ricette cosmetiche: per far crescere i capelli, o renderli biondi e ricci; per truccare il viso; per rendere le mani bianche e belle come l’avorio.[80] Fu proprio a Milano, nei primi anni della sua vita, che Caterina ebbe modo di sviluppare il suo interesse per l’erboristeria, frequentando la duchessa Bona di Savoia e il suo speziale, Cristoforo Brugora, che aveva creato nella capitale del Ducato Sforzesco, nei pressi di Sant’Ambrogio, lambito dalle acque del Nirone, uno dei primi orti botanici, dove - al riparo da occhi indiscreti - coltivava le essenze che gli erano necessarie alla produzione dei medicinali.[81] Durante la terribile pestilenza del 1485, che aveva colpito duramente Milano e molte altre città della Penisola, Caterina Sforza, poco più che ventenne, si trovava a Forlì intenta a girovagare di persona per i quartieri più umili della città dispensando i suoi medicamenti. A chi le raccomandava prudenza rispondeva che la peste non le faceva paura per averla vista spesso a Roma, e per aver constatato che “di quella malattia periscono solamente persone “vili e abbiette”[82]. L’osservazione era giusta nel senso che i tuguri privi di igiene favorivano il proliferare dei vettori dell’epidemia.
Alla pari della loro illustre concittadina, molte donne milanesi impiegavano cospicui capitali o esercitavano di persona l’arte dello speziale, come emerge dai documenti notarili di fine ‘400.
Nell’agosto del 1481 una vedova passata a seconde nozze, ma del tutto autonoma sia dal primo che dal secondo marito, impiegava nell’arte farmaceutica ben 1.200 lire che le venivano dall’eredità paterna. La donna, già proprietaria di una bottega contigua alla sua abitazione, nella parrocchia di S. Simpliciano a porta Comasina, si associò per 6 anni con uno speziale di Monza al quale avrebbe fornito il capitale per avviare l’attività e affittato la bottega. Il socio, privo di denaro, avrebbe conferito soltanto la propria opera, lavorando materialmente e occupandosi dell’amministrazione dell’attività (acquisti, vendite, compilazione dei libri mastri, rendiconti periodici alla socia di capitale). Si trattava cioè di un’imprenditrice pura, detentrice di una somma consistente, che ritenne opportuno investire in un’attività evidentemente lucrosa. In quegli anni infatti la peste era endemica a Milano, e culminò nella terribile epidemia del 1485. Guadagni e perdite sarebbero stati divisi a metà fra i due contraenti.[83]
In altri casi le donne milanesi, oltre ad essere proprietarie della farmacia, la gestivano di persona, padroneggiando perfettamente tutte le nozioni necessarie a svolgere l’attività, tanto da poter istruire degli apprendisti. In un contratto di lavoro del 1503 un padre metteva a bottega il figlio presso una vedova titolare di una farmacia nella parrocchia di S. Lorenzo Maggiore fuori porta Ticinese. La donna avrebbe istruito il ragazzo mettendolo a conoscenza di tutti i segreti dell’arte. Si trattava di un contratto di apprendistato a pieno titolo, realmente finalizzato all’istruzione del discepolo: quest’ultimo infatti non veniva retribuito (come accadeva invece per i semplici inservienti), ma era la maestra a ricevere dal padre del ragazzo un compenso per l’insegnamento che gli avrebbe impartito. Anche in questo caso la farmacista era pienamente autonoma e agiva senza la mediazione di alcun parente.[84]
Nel luglio del 1524, durante una terribile pestilenza, una giovane donna nubile, malata probabilmente di peste, nominando erede universale la madre, rivelava nel suo testamento molti particolari della propria esistenza. Di famiglia altolocata (come lascia intuire la tomba di famiglia designata per la sepoltura, e l’appellativo di nobile, con cui viene designata la genitrice), Caterina de Camerino detta de Barziis era proprietaria di una bottega di speziale situata accanto alla sua abitazione nella parrocchia di S. Lorenzo Maggiore a porta Ticinese. Aveva gestito personalmente l’attività fino alla malattia, affidandola poi ad un collaboratore esperto e fidato che avrebbe avuto il compito di mandare avanti l’attività a favore della madre di Caterina, dopo la morte di quest’ultima. Come compenso per il suo importante incarico, il gestore della spezieria avrebbe ereditato alla scomparsa della madre di Caterina tutti gli utensili d’argento, rame e bronzo e tutti i medicamenti contenuti nella bottega. La bambina che la giovane moribonda aveva adottato dall’Ospedale Maggiore sarebbe rimasta in casa sua, con l’anziana madre, spesata di vitto e alloggio e con una piccola dote.[85]
Questa breve rassegna documentaria offre alcuni punti di riferimento ben precisi: una giovane nubile e due vedove, completamente autonome dai defunti mariti sia economicamente, sia per tipologia di attività, erano in grado di intraprendere come socie di capitale e di gestire personalmente la complessa arte dello speziale, dei cui segreti avevano una padronanza tale da poterli insegnare ad apprendisti di sesso maschile. Tutto questo avveniva ufficialmente, col beneplacito del notaio, che (nel medioevo) garantiva la legalità degli atti, e senza che la corporazione degli speziali si pronunciasse in merito.
Imprenditoria, autofinanziamento e credito
Il quadro che ci si prospetta è dunque quello di donne impiegate in tutti i possibili settori, imprenditrici che si autofinanziavano con propri capitali ottenuti dalla vendita di abiti e gioielli; retribuzioni commisurate “alle reali capacità” e quindi non dipendenti dal genere; donne che col proprio lavoro riuscivano a mantenere sé stesse e familiari in difficoltà, o a saldare i debiti dei mariti; nobildonne impegnate nelle attività più varie: dall’organizzazione di laboratori per il ricamo, alla gestione di miniere, alla direzione di opere di bonifica, alla creazione di caseifici, alla gestione di alberghi. Lucrezia Borgia, duchessa di Ferrara, ad esempio, era un’abilissima imprenditrice agricola impegnata in lavori di bonifica e in svariate attività che non raramente finanziava vendendo i propri gioielli: nel 1516 sacrificò una catena d’oro per sovvenzionare il rifacimento degli argini di un fiume, e poco dopo impiegò una perla e un rubino per avviare un allevamento di bufale, della cui mozzarella era golosa. [86] Tra il 1513 ed il 1519 (anno in cui morì), spinta dalle difficoltà economiche in cui si trovava il marito Alfonso d’Este, la duchessa aveva infatti iniziato un’instancabile opera di bonifica dei terreni del ferrarese utilizzando sia i proventi dell’eredità di uno dei figli, sia quelli derivanti dalla vendita dei propri gioielli. Seguendo una strategia del tutto originale, Lucrezia non impiegava capitali nell’acquisto dei terreni, ma pattuiva con i proprietari e le comunità la realizzazione dei lavori in cambio di una parte delle terre bonificate, sulle quali dava vita a molteplici attività (coltivazione del grano, e soprattutto allevamento di ovini e bovini, produzione di lana, pellami, formaggio). I proventi venivano portati a Ferrara e pesati nel palazzo della duchessa (vera e propria struttura commerciale dotata anche di un forno per la cottura dei mattoni e di un filatoio), per poi essere ridistribuiti nelle botteghe cittadine. Lucrezia finanziava personalmente i lavori di bonifica, ma sapeva servirsi anche delle prestazioni obbligatorie e gratuite delle comunità residenti, con argomenti del tutto convincenti. In questo modo riuscì in pochi anni ad ottenere ingenti guadagni e ad assicurarsi un notevole patrimonio fondiario.[87]
Ugualmente, negli anni ’90 del ’400, la nobildonna romana Cristofora Margani vedova del mercante pisano Alfonso Gaetani, ed unica erede di 1/3 delle miniere di allume di Tolfa (Civitavecchia) controllava in prima persona il lavoro di produzione e si occupava sia della risoluzione delle questioni con i minatori, sia dei complessi rapporti con il mondo mercantile, gestendo per parecchi anni un universo composito ed articolato, in cui confluivano forze economico-sociali diverse (manovalanza, artigianato, mercatura), fino alla consegna dell’allume alla Camera Apostolica.[88]
Tra gli altri settori in cui le donne si distinguevano va sicuramente ricordata, in particolare a Venezia, l’arte della stampa: oltre alle numerose che vi lavoravano a vario titolo, nei primi anni del ‘500 almeno due giunsero a firmare le pubblicazioni come editrici. In un caso si trattava della vedova di un editore milanese, nell’altro di una nobildonna greca (Anna Notaras) emigrata a Venezia da Costantinopoli, che non aveva ereditato l’attività, ma che l’aveva intrapresa autonomamente e in prima persona, per sovvenzionare e diffondere nella città lagunare la cultura della madrepatria.[89] Ancora a Venezia emerge poi la figura di Paola da Messina, figlia del pittore Antonello, che con i suoi consistenti capitali e le sue intense relazioni culturali e sociali condizionò la politica editoriale degli anni ‘70/’80 del ‘400, attraverso 3 matrimoni con i primi tipografi veneziani (Giovanni da Spira, Giovanni da Colonia, Rinaldo da Nimega) e l’alleanza commerciale strategica con l’importante editore Nicolas Jenson. Sotto il profilo imprenditoriale e monopolistico, Paola non trascurò alcuna opportunità, fino a combinare, nel 1477, il matrimonio della propria figlia con un importante libraio, di cui la nipote di Antonello da Messina ereditò l’azienda, guidandola fino al 1511.[90]
Altre donne operarono ai vertici del settore librario cinquecentesco a Milano, Firenze, Torino, Novara, Verona, Napoli, Messina, Camerino.[91]
L’imprenditoria femminile si esplicava ovunque ad ogni livello sociale e negli ambiti più vari, tra i quali la frutticoltura. In quest’ultimo settore è testimoniata ad esempio l’attività di una donna milanese che nel 1479 gestiva, con altri tre produttori specializzati, una società di cui era la principale rappresentante, trattando gli affari in prima persona e come delegata degli altri componenti del sodalizio, tutti commercianti di frutta di provata esperienza. Non si trattava dunque di una semplice venditrice al minuto, ma di una vera e propria imprenditrice che si occupava dell’intero ciclo produttivo di un’attività svolta completamente in ambito cittadino, dove abbondavano giardini, orti e spazi verdi, costantemente messi a reddito con la coltivazione di svariate qualità di frutta. Pienamente calata nella frenetica attività di un settore che, per la deperibilità del prodotto, richiedeva la gestione contemporanea ed in tempi brevi di una miriade di operazioni diverse (stipulazione dei contratti di affitto della sole piante, cessione ad altri commercianti specializzati delle qualità di frutta che non interessavano, distribuzione del prodotto sui banchi delle principali piazze cittadine gestiti tramite salariati), la donna fu in grado di prendere in locazione tutte le piante del principale frutteto cittadino, per un canone astronomico, rivendendo poi ad un altro fruttarolo parte del raccolto, e garantendogli anche un banco per la vendita al dettaglio.[92]
Per quel che concerne il reperimento dei capitali, la prassi abituale per mettersi in affari per le donne era quella di autofinanziarsi con la propria dote o con la vendita di abiti e gioielli, espediente a cui ricorrevano persone di varia estrazione sociale (come accennato, vi fece ricorso ripetutamente persino Lucrezia Borgia). A Roma nel xv secolo, ad esempio, vigeva ampiamente la consuetudine di vendere o cedere in affitto gioielli, perle, coralli, ed abiti di valore per procurarsi le risorse necessarie ad avviare un’attività, o di utilizzare la dote per finanziare operazioni di microcredito, in particolare a favore di aziende femminili, ma non solo.[93] La cosa era tanto diffusa che esistevano apposite figure professionali, le “imperlatrici”, dotate delle competenze tecniche adeguate a valutare i preziosi che altre donne cedevano in pegno per ottenere somme da investire in attività manifatturiere.[94] Analogamente nella Penisola Iberica e in Germania la valutazione di oggetti di un certo valore veniva affidata di preferenza alle donne, molte delle quali avevano specifiche competenze in merito: erano infatti informate con precisione sulle fluttuazioni della domanda di determinati prodotti, sulla solvibilità dei vicini, sull’onestà dei fornitori delle materie prime. In alcune città della Spagna, alla fine del xv secolo, acquisirono una tale professionalità in questo campo da essere apertamente riconosciute come professioniste della valutazione: emettevano dei veri e propri arbitrati, insieme ad altre donne o ad uomini, per determinare la giusta stima di oggetti di vario tipo.[95]
Nella Roma quattrocentesca non raramente prestiti femminili di importo piuttosto cospicuo (e per i quali veniva percepito un interesse) finanziavano aziende maschili di solito estranee all’ambito familiare. Nel 1445 un maestro lanaiolo lombardo residente nella città ottenne un prestito di 100 fiorini dalla moglie di un tessitore tedesco, e utilizzò la somma per acquistare 2 telai dal marito della donna. Nel 1469 una vedova finanziò con ben 300 ducati una società per l’arte della lana da cui avrebbe ottenuto un cospicuo interesse mascherato dagli utili della compagnia. Nel 1470 un funaio si rivolse ancora ad una donna per avere i 50 ducati necessari ad avviare l’attività, fornendole come garanzia l’ipoteca sulla propria bottega. Nel 1467 due giovani calzolai poterono iniziare a lavorare grazie ai 70 ducati che la madre aveva preso in prestito da una conoscente dandole in garanzia un immobile, mentre gli utensili della bottega vennero acquistati grazie al denaro che la moglie di uno dei due aveva ricavato dalla vendita di alcuni dei propri gioielli. Un fabbricante di candele, previa ipoteca di alcuni beni, ebbe in prestito da una donna 40 ducati. La moglie di un panettiere fornì 10 ducati ad un sarto, mentre quella di un merciaio tedesco finanziò con ben 80 ducati un altro merciaio tedesco.[96] Nel 1476 una sarta romana erogò ben 160 ducati a un nobile della città, ottenendo in garanzia una casa di cui avrebbe potuto disporre a suo piacimento, affittandola e ricavandone un reddito, fino alla restituzione del denaro.[97]
La disponibilità di capitali di molte donne, spesso di ceto medio-basso, è testimoniata anche nella Siena trecentesca dal cospicuo numero di conti correnti femminili esistenti presso il banco dell’ospedale di Santa Maria della Scala.[98]
Ancora nella Città Eterna l’interesse femminile era rivolto soprattutto verso il business dell’ospitalità ai pellegrini che alimentava un giro d’affari notevolissimo: numerose perciò le imprenditrici di ogni livello ed estrazione sociale che gestivano direttamente uno o più alberghi, o acquistavano grandi edifici da dare in gestione a tale scopo.[99] La madre di Cesare e di Lucrezia Borgia, Vannozza Cattanei, nei primissimi anni del ‘500 era proprietaria di due strutture ricettive che le garantivano una cospicua rendita, e che aveva fatto ristrutturare vendendo i propri gioielli.[100]
La gestione degli alberghi romani era così redditizia –soprattutto in prossimità degli anni santi– (si aggirava intorno all’8-10% annuo), da attirare anche investitrici forestiere, come quella Beatrice da Marsiglia che nel 1472 prese in affitto un immobile in una zona centralissima della città (difronte alla residenza del cardinale Rodrigo Borgia, il futuro papa Alessandro VI), da adibire a struttura ricettiva.[101]
L’edilizia: manovalanza e imprenditoria
E’ sorprendente il fatto che in tutta Europa le donne medievali fossero attivissime anche in compiti molto faticosi, nell’edilizia e nelle miniere.[102] In Francia e Spagna partecipavano come manovalanza alla costruzione delle cattedrali (secc.xiv-xv). A Siena e a Pavia scavavano acquedotti e canali. A Messina contribuivano all’edificazione delle mura cittadine (1282). Le converse che lavoravano negli ospedali in area emiliana (secc. xiii-xiv), accanto ai tradizionali compiti di assistenza ai degenti, non raramente venivano reclutate, insieme agli uomini, per scavi e realizzazione di infrastrutture (strade, ponti, canali) in ambito urbano e rurale.[103]
Nel ‘300 il lavoro femminile era diffuso nei cantieri della Toscana: a Siena ancora per la costruzione delle mura cittadine, come testimonia Ambrogio Lorenzetti nel ‘Buon Governo’ (1338-1339), nello scavo dell’acquedotto, e nel cantiere del Duomo, dove, nella prima parte del secolo compaiono “chalcinaiuole”, donne manovali o che portavano calcina, o “che rechano rena”. Nel territorio senese, tra l’ottobre 1354 e il marzo 1355, “manovagli e femine che lavorano a giornata” parteciparono alla costruzione del cassero di Montepulciano. Le retribuzioni di questa manodopera femminile equivalevano costantemente a circa la metà del salario dei manovali di livello più basso. Rare invece le operaie nel cantiere del Duomo di Milano, e del tutto assenti in quello del Duomo di Firenze, dove compaiono alla fine del ‘300, anche se in modo discontinuo, i bambini.[104]
Tra i pochi esempi documentati per l’Italia va segnalato quello di alcune località nei pressi di Pavia (Sartirana, Palestro, Castelnovetto), dove da un elenco, risalente al 1474/1475, del personale impiegato nello scavo di un canale, emerge che su un totale di 640 lavoratori ben 284 erano donne,[105] spesso imparentate fra loro, coadiuvate da bambine e bambini, e coordinate da una sovrastante. Percepivano tutte la stessa retribuzione, corrispondente ai due terzi di quanto guadagnato dagli uomini, e superiore del 16% circa rispetto al compenso ordinario delle operaie giornaliere dei cantieri trecenteschi della Toscana e della maggior parte delle città francesi e spagnole.[106] Nella lista della lavoratrici erano compresi anche circa 20 ragazzi, che percepivano lo stesso stipendio delle donne, 4 bambini , e persino 2 o 3 bambine, retribuite la metà rispetto alle donne.[107]
La differenza di compensi non è comunque da imputare al genere: in alcuni cantieri della Penisola Iberica (sec.xiv e xv) sono documentati casi di operaie dotate di forza particolare, in grado di svolgere le stesse mansioni degli uomini, e retribuite quanto loro.[108] E come nell’edilizia, anche in tutti gli altri settori il genere non costituiva il fattore determinante nella fissazione dei salari: le retribuzioni risultavano commisurate alle capacità lavorative del singolo individuo, indipendentemente dal fatto che si trattasse di un uomo o di una donna.[109] La manodopera femminile era anzi retribuita di più in quelle mansioni in cui rendeva di più (ad esempio nella realizzazione dei rivestimenti per le armature nell’Avignone di fine ‘300,[110] o nella produzione di passamanerie dorate a Venezia nel ‘500)[111], e viceversa meno quando le sue capacità risultavano inferiori a quelle maschili. Quando poi la resa era la stessa (nella tessitura, ad esempio) lavoratore e lavoratrice venivano pagati nello stesso modo.[112]
Neppure nell’edilizia mancava l’imprenditoria femminile: a Milano, all’inizio del ‘500, alcune fornaci che rifornivano di laterizi i cantieri delle principali costruzioni civili e religiose cittadine erano di proprietà e gestite da donne.[113]
Non mancavano poi le scultrici, come la bolognese Properzia de’ Rossi (1490-1530), la sola —a detta del Vasari— che osò “mettersi con le tenere e bianchissime mani nelle cose meccaniche, e fra la ruvidezza dei marmi e l’asprezza del ferro” , realizzando raffinati bassorilievi per il cantiere di San Petronio, ma specializzata anche in miniature intagliate in materiali poveri come i noccioli di ciliegia e di prugna.[114] Al ‘600 risale invece la prima menzione ufficiale di una donna architetto, Plautilla Bricci, che nei cantieri della Roma barocca poteva chiedere compensi superiori a quelli del Bernini.[115]
Altre attività pesanti, nocive, pericolose
In Italia come in tutta Europa, le donne non si sottraevano neppure ad attività particolarmente pesanti o nocive, o ad incombenze tradizionalmente maschili. A Cosenza nel primo ‘200 la sorella di un sacerdote svolgeva la professione di sacrestana, mentre altre gestivano mulini come dipendenti del vescovo cosentino.[116] A Cortona nel ‘300 le donne che gestivano taverne, al pari degli uomini, avevano l’obbligo di intimare ai loro ospiti di deporre le armi.[117] Ancora a Cortona, tra il 1325 e il 1351, era previsto che potessero aiutare la squadra cittadina dei pompieri a spegnere gli incendi, ed era loro consentito tagliare nei boschi la legna bruciata e servirsene a proprio piacimento.[118]
A Milano negli ultimi decenni del ‘400 dirigevano botteghe per la tintura del cuoio, attività riconosciuta fin da quell’epoca estremamente inquinante e pericolosa per la salute, o esercitavano di persona il mestiere.[119] Altre gestivano la concia delle pelli da pelliccia (pratica altrettanto nociva e inquinante), dedicandosi anche in prima persona all’attività.[120] Altre ancora partecipavano materialmente alla produzione degli specchi in vetro e in metallo (incombenza anch’essa alquanto pericolosa), o gestivano rivendite di vino.[121]
Tra ‘400 e ‘500 non erano affatto rari anche in altre città italiane i casi di donne che gestivano in prima persona aziende vetrarie, soprattutto in quanto eredi dell’attività del marito. Nel 1429 a Vicenza una vedova era in società con un vetraio di Ferrara, e un’altra a Treviso nel 1434 gestiva una manifattura di successo nel medesimo settore.[122] A Firenze , a partire dal 1527, la vedova del più importante vetraio della città, iscrittasi all’arte dei Medici e Speziali per poterne continuare l’attività, fu in grado di ampliare la manifattura del marito, acquistando l’immobile sede della bottega.[123]
Ancora a Firenze, dal catasto del 1427, sono emerse imprenditrici nel settore della pellicceria e in quello ortofrutticolo (queste ultime in grado di gestire tutto il processo produttivo, fino alla locazione di spazi vendita sulla piazza del mercato); artigiane autonome come la fabbricante di pettini di 61 anni che gestiva un’impresa di discrete proporzioni tanto da essere proprietaria degli utensili, tenere un libro mastro ed essere in contatto con numerosi mercanti, e in grado di vivere del proprio lavoro (come dichiarò agli ufficiali del catasto)[124].
A Roma nel ‘400 le donne erano largamente presenti nelle corporazioni dei calzolai, dei ciabattini e dei sarti. Nel 1447 una calzolaia venne multata per aver gettato in strada i residui della concia.[125] Nel 1489 a Siracusa, una donna gestiva il macello cittadino, privilegio da sempre appartenuto alla sua famiglia, e che comportava l’amministrazione di un notevole flusso di denaro,[126] mentre a Siena fin dalla metà del ‘200 non mancavano le macellaie.[127]
Ad Aosta nel ‘400 e all’inizio del ‘500 gruppi di donne coordinate dall’amministratrice del priorato di Sant’Orso fabbricavano le candele di sego con stoppini in cotone o canapa sia per la collegiata, sia per l’illuminazione dei castelli di Verrès e di Issogne. Svolgevano contemporaneamente anche altre mansioni, soprattutto quella di lavandaie.[128]
L’Italia meridionale e le isole
Anche nel Sud della Penisola si riscontrano tutte le caratteristiche emerse ovunque in Italia e in Europa: lavoro femminile universalmente diffuso in ogni settore e a tutti i livelli (manifatturiero, imprenditoriale e mercantile), almeno a partire dal ‘200; nobildonne attive nel commercio e propense ad autofinanziarsi con la vendita di oggetti preziosi; autonomia lavorativa ed economica rispetto ai soggetti maschili; assenza delle donne dalla documentazione pubblica e corporativa, ad eccezione delle situazioni in cui era necessario mettere sotto controllo il loro operato, e loro presenza invece nella fonte notarile.
A Salerno e ad Amalfi, fin dal xii secolo, e ancor più nel xiii, le prestatrici di denaro che agivano a proprio nome e in prima persona erano numerosissime, e in numero notevole anche quelle che svolgevano attività commerciali ad alto livello ed erano proprietarie di fondaci.[129] Nel 1202 una salernitana gestiva un forno in cui lavorava di persona giorno e notte, mentre ad Eboli, nello stesso periodo (1147), è menzionata una “Gemma calceolaria”, oltre a più numerose operaie salariate o schiave.[130] Ad Amalfi nel xii secolo, nonostante la loro presenza spesso nascosta, se ne percepisce comunque il ruolo attivo nei traffici e nelle transazioni in cui potevano mettere a frutto i capitali ottenuti dalla dote, favorite in questo dalla maggiore capacità giuridica conferita loro dal diritto romano vigente nella città, e non goduta invece nelle aree (come quella pugliese e salernitana) dove la legge longobarda vigente imponeva la presenza di un garante (il mundualdo)[131].
A Napoli le prime notizie di laboratori per la tessitura del lino gestiti da donne, che davano lavoro ad un certo numero di operaie, risalgono al 1026 e al 1073. Una di loro lasciò in eredità ad una parente tutta l’attrezzatura del suo opificio: i pettini per la cardatura, la caldaia, tini e pestelli vari e il telaio. Si trattava cioè di una produzione di una certa entità, destinata al mercato.[132] Nella stessa epoca (secc.xi-xii) le donne napoletane si dedicavano alacremente anche all’attività creditizia nella più completa autonomia, investendo in prestiti ad interesse la propria dote o patrimoni più cospicui, frutto del loro lavoro. E anche le esponenti di ceti elevati non facevano eccezione.[133]
Nel ‘400, a Napoli, ad Aversa e a Sorrento numerose erano le albergatrici che lavoravano da sole o in società, e le donne che prendevano denaro in prestito per investirlo negli affari più diversi, o che finanziavano varie attività anche maschili con i propri capitali.[134] Siamo insomma difronte alla “costante presenza di donne istruite, provviste di un capitale monetario e immobiliare, dotate di una certa capacità imprenditoriale, che le rendono capaci di essere coprotagoniste della vita economica medievale meridionale”[135].
La Sicilia
In tutta la Sicilia, tra il xiii e il xv secolo, donne di ogni ceto sociale erano impegnate in svariate attività che spesso non rientravano affatto tra quelle tipicamente femminili: come accennato, nel 1282 le messinesi – sia pure in una situazione straordinaria come l’assedio di Carlo d’Angiò - parteciparono alla costruzione delle mura cittadine, ottenendo l’elogio di Giovanni Villani.[136]
Numerose le palermitane che nel xiii secolo stipulavano contratti con mercanti barcellonesi o messinesi, o investivano in carichi di carne salata e formaggio da esportare a Genova, o commerciavano cotone e schiavi,[137] o costituivano società per la concia delle pelli (sec. xiii)[138], o gestivano botteghe per la produzione di zoccoli, coadiuvate da lavoratori dipendenti (1287)[139], o ateliers di calzoleria (1426), o erano titolari e conduttrici di locande. Una di loro costituì una società per la realizzazione di lavori agricoli (1332-1333), in cui avrebbe fornito la metà delle sementi e degli utensili necessari, oltre alla metà del salario da destinare ad un bracciante giornaliero. L’altro socio avrebbe partecipato anche materialmente all’attività col proprio lavoro per il quale avrebbe percepito un compenso supplementare.[140] Va anche sottolineato che in questo, come nella maggior parte degli altri casi, non si trattava necessariamente di vedove, ma per lo più di donne sposate il cui marito svolgeva un’altra attività completamente autonoma da quella della consorte.
Negli stessi anni (1332-1333), sempre a Palermo, una donna finanziò una società per l’arte della lana in cui avrebbero lavorato due coniugi come soci d’opera: si trattava, tra l’altro, di un settore a quell’epoca in piena espansione nella città, e i cui prodotti godevano di un notevole successo, tanto da essere esportati nel nord della Penisola fino a Genova e ad Alessandria.[141]
Persino le nobildonne partecipavano attivamente alla vita economica delle città siciliane, spesso autofinanziandosi con la propria dote. Nel secolo xv, oltre alla mercantessa catalana Caterina Llull,[142] operante nell’isola, sono documentate anche molte altre esponenti dei ceti più alti, attive a livello imprenditoriale e mercantile, come la messinese che all’inizio del ‘400 finanziò le proprie attività commerciali vendendo oggetti preziosi (tra i quali ben 8 libri di diritto); o la “nobilis domina” che nel 1426, ancora a Messina, commerciava vino; o le numerose nobildonne che a Trapani erano impegnate nel commercio e nella manifattura del corallo: una di loro vendeva il materiale grezzo ad un mercante catalano, mentre un’altra era in rapporti di affari con un operatore ebreo al quale forniva il prezioso prodotto già sbozzato in grani di rosario.[143]
Nello stesso periodo numerose messinesi di ogni ceto sociale commerciavano seta grezza e veli di cotone.[144]
Come nel resto dell’Italia e dell’Europa, anche in Sicilia le attività femminili emergono nel loro rapporto con le istituzioni pubbliche e con quelle corporative soltanto quando sussisteva l’esigenza di controllarle. A tale proposito appunto, i capitoli dei venditori e delle venditrici di tessuti e capi di abbigliamento di Messina (fine ‘300) stabilivano che questi commercianti, uomini e donne, dovessero prestare ampie garanzie (con eventuale cauzione) del corretto svolgimento della loro attività ai magistrati preposti al “consolato del mare”, la magistratura preposta alla regolamentazione delle attività economiche cittadine. Venivano inoltre determinate le modalità del loro compenso. Ancora una volta, dunque, era l’esigenza di porlo sotto stretta sorveglianza, a far emergere nelle fonti pubbliche e in quelle corporative il lavoro femminile, tanto più che non si trattava di articoli di poco conto: nel 1468, infatti, sono documentate due di queste venditrici come intermediarie per indumenti femminili in prezioso panno di Bruges, o confezionati con la pregiatissima lana di Londra.[145]
La Sardegna
Anche in Sardegna, fin dall’xi secolo, il lavoro femminile era considerato alla pari con quello maschile, in una società che consentiva alla donna di gestire in prima persona il proprio patrimonio, e ai figli di assumere indifferentemente il cognome del padre o quello della madre. Svolgevano attività di vario tipo: aiutanti dei funzionari statali addetti alla vinificazione, lavoravano nei campi, macinavano il grano, confezionavano il pane, oltre alle tradizionali incombenze come la filatura e la tessitura, che non venivano però praticate in ambito domestico, ma nei “ginecei”, ovvero laboratori statali sotto la supervisione di appositi funzionari. Si trattava cioè di una produzione di notevole livello, concepita sia per le necessità della corte giudicale, sia per l’esportazione. E tra i materiali trattati c’era, già nel ix secolo, il preziosissimo bisso marino, filamento sottilissimo, del colore dell’oro, del rame o dell’argento, prodotto da una particolare conchiglia, e che per essere filato richiedeva fusi particolari e grande abilità e perizia tecnica. Papa Leone IV, nel ix secolo appunto, chiese ai laboratori sardi una fornitura di questo tessuto diafano e impalpabile, affermando che l’avrebbe pagata qualunque prezzo, perché riteneva che soltanto i paramenti intessuti di bisso fossero degni di essere indossati nelle festività più solenni.[146]
Lavoro e disabilita’
Se la condizione ordinaria delle donne medievali era quella sin qui descritta, eventi particolari potevano catapultarle nella miseria più nera. Tra questi soprattutto la malattia e la disabilità. Dalle fonti agiografiche, recentemente prese in considerazione per la storia della società medievale, emerge appunto la preoccupazione costante (per le donne come per gli uomini) di perdere l’autonomia lavorativa per potersi procurare il pane quotidiano, cosa che si verificava puntualmente in caso di malattia e di disabilità.[147] Nelle “vite dei santi” e nei processi di canonizzazione, il nesso tra malattia e indigenza è costante, e il ritorno alla salute attraverso il miracolo significava soprattutto recupero dell’autosufficienza nella vita quotidiana.
Un elenco duecentesco degli assistiti dalla Misericordia di Bergamo enumera molte malate, tra cui due cieche, una paralitica, una sorda.[148] Nel 1427 la fiorentina Biagia, tessitrice di drappi di lino, sola e malata, viveva alla giornata perchè la precarietà della sua salute la esponeva costantemente al rischio del totale tracollo economico.[149] Drammatica poi la condizione di una donna di Spoleto, già molto povera, che si era rotta una spalla cadendo, per cui non poteva adoperare il braccio, e non era più in grado di guadagnarsi da vivere. La disgraziata, non potendo fare altro, rivolse una preghiera a Santa Chiara da Montefalco chiedendo di guarirla, in modo da riuscire a lavorare e a sostentarsi.[150] Se perdere la salute era una sventura, perdere la vista rappresentava una tragedia senza eguali[151] perché —come disse una testimone interrogata durante il processo di canonizzazione di San Nicola da Tolentino (1325)— non era più possibile “distinguere un filo grosso da uno sottile, una moneta falsa da una vera, il cielo sereno dal cielo nuvoloso”[152]. Sibillina da Pavia, cieca dall’età di 12 anni, si doleva della sua infermità non tanto per l’impossibilità di godere delle meraviglie della natura, ma soprattutto per il fatto di non potersi più procurare autonomamente di che vivere. Aveva tentato di filare, ma gli occhi spenti glielo impedivano, per cui la malattia aveva accresciuto la sua povertà. La bimba allora aveva rivolto le sue preghiere a S.Domenico implorando la guarigione, ma le sue aspettative erano rimaste deluse.[153]
Questa menomazione toccava in particolare le donne, che, oltre ai tradizionali lavori di filatura e di cucito, spesso esercitavano attività in cui era richiesta una notevolissima precisione (infilaperle, filatrici d’oro, produttrici di perle di vetro e di corallo), e quindi una vista perfetta. Significativo in proposito il fatto che non raramente le donne medico fossero specializzate proprio nelle patologie oculari.[154] La drammaticità della condizione delle infilaperle che avendo perso l’acutezza visiva non erano più in grado di lavorare, viene descritta dal medico modenese Bernardino Ramazzini (1633-1714), in un quadro interessantissimo, anche retrospettivo: “ho conosciuto in questa città [Ferrara] una donna ebrea, di eccezionale bravura nell’infilare perle, e le sapeva disporre in tale ordine ed al posto giusto, che non ci si accorgeva se qualche perla aveva difetti o magagne; da questo lavoro si procurò un guadagno non indifferente, ma giunta ai quarant’anni dovette abbandonarlo non trovando aiuto in nessun tipo di occhiali”[155]. Profondamente partecipe della tragicità di queste situazioni a livello personale e sociale, il Ramazzini, pur consapevole dell’impossibilità di porvi rimedio, cercava tuttavia di dare alle disgraziate creature consigli per prevenire, se non l’insorgere, almeno l’aggravarsi del male:
io non saprei dire con quali rimedi si possono soccorrere questi lavoratori nella loro disgrazia; infatti non è facile persuaderli a lasciare quel mestiere da cui ricavano guadagno e cibo, e il medico non ha un rimedio con cui restituire agli occhi, quando il male è già avanzato, il vigore e la mobilità perduti (…)[156].
Nelle “vite dei santi” e nei processi di canonizzazione,[157] non sono rare le descrizioni di donne inabili al lavoro per la perdita dell’uso della mano destra, o paralizzate, o cieche,[158] che i familiari conducevano al sepolcro di un santo, col pretesto di ottenere un miracolo, abbandonandole poi in quel luogo per non doversene accollare il mantenimento.[159] Margherita da Città di Castello (fine anni ’80 del ‘200-1320), di famiglia altolocata, ma “ceca, parvula ac diformis” dalla nascita, venne fatta chiudere dal padre in una camera del suo maniero, in modo che nessuno si accorgesse di lei, e poi abbandonata a Città di Castello, presso la tomba di un santo invocato perché la miracolasse. La bimba rimase sola a girovagare per il borgo costretta a mendicare il cibo quotidiano, fino a quando fu accolta nel monastero di Santa Margherita, da cui venne però espulsa poco dopo. Trovò infine approdo nella casa di due coniugi che la adottarono, e da quel momento sono noti i suoi miracoli, soprattutto a favore di altri disabili.[160]
La famiglia dunque spesso non aiutava i suoi componenti disabili,[161] al punto che talvolta le donne sole erano avvantaggiate rispetto a quelle sposate, che in caso di grave infermità venivano abbandonate dai mariti, o costrette a mendicare per contribuire comunque ai carichi familiari.[162]
[1] Per una sintesi di questi studi, il cui raffronto ha portato a ribaltare completamente il quadro che si aveva finora sul lavoro femminile medievale, si rimanda a Maria Paola ZANOBONI, Donne al lavoro nell’Italia e nell’Europa medievali (secc.xiii-xv), Milano, Jouvence, Mimesis Edizioni, 2016. Per una sintesi della storiografia sull’argomento: Maria Giuseppina MUZZARELLI, Sul lavoro delle donne nel Medioevo: letture recenti e meno recenti, in Roberta MUCCIARELLI e Michele PELLEGRINI (eds.), Il tarlo dello storico. Studi di allievi e amici per Gabriella Piccinni, Arcidosso (Grosseto), Effigi, 2021, tomo II, pp. 1051-1062. Sulle medesime tematiche riferite all’età moderna: Anna BELLAVITIS, Il lavoro delle donne nelle città dell’Europa moderna, Roma, Viella, 2016.
[2] ZANOBONI, Donne al lavoro nell’Italia e nell’Europa medievali, op.cit, pp. 69-78.
[3] Francesca MORANDINI (ed.), Statuti delle Arti degli oliandoli e pizzicagnoli e dei beccai di Firenze (1318-1346), Firenze, Olschki, 1961.
[4] Queste idee, del tutto nuove, sul rapporto tra donne e corporazioni e sull’apprendistato femminile sono state da me elaborate e dimostrate attraverso l’esame di una grandissima quantità di materiale nel volume ZANOBONI, Donne al lavoro nell’Italia e nell’Europa medievali, op. cit, a cui si rimanda per l’elenco degli statuti e degli studi consultati.
[5] Per la casistica sull’argomento (prodotti annonari, settore sanitario e materie prime preziose), si rimanda a ZANOBONI, Donne al lavoro nell’Italia e nell’Europa medievali, op. cit, pp. 44-52. Le norme corporative tese al controllo del lavoro femminile nel settore annonario erano numerosissime soprattutto per le panificatrici, che ricorrono negli statuti trecenteschi e quattrocenteschi di Firenze, Cortona, Ascoli Piceno, Milano, per citarne solo alcuni (Ibídem).
[6] Ibídem, cap. 2, pp. 29-35; cap. 3, pp. 41-69.
[7] ZANOBONI, Donne al lavoro, op. cit., cap. 3, p. 69.
[8] Ibídem, p. 67.
[9] Maria Paola ZANOBONI, Povertà femminile nel medioevo. Istantanee di vita quotidiana, Milano, Jouvence [Mimesis Edizioni], 2018.
[10]Per la casistica cfr. ZANOBONI, Donne al lavoro nell’Italia e nell’Europa medievali, op. cit., pp. 143-148; EAD., Povertà femminile nel medioevo, op. cit., pp. 65-70 e passim.
[11] Sull’entità dei salari e sulla capacità delle donne sole di aiutare col proprio stipendio familiari in difficoltà: Cfr. ZANOBONI, Donne al lavoro nell’Italia e nell’Europa, op. cit, cap. 7; e, per il secondo aspetto, soprattutto: Ead., Povertà femminile nel medioevo, op. cit.
[12] Anna ZANINONI, “‘Foemina, domina, massara’. Appunti sulla condizione socio-giuridica della donna a Piacenza tra xii e xiii secolo”, Nuova Rivista Storica, LXXIII (1989), pp. 181-190.
[13] L’altra metà della MIA. Le donne, testi di Maria Teresa BROLIS e Paolo CAVALIERI, Bergamo, Bolis Edizioni, 2015, pp. 33-35.
[14] Franco FRANCESCHI, I tedeschi e l'Arte della Lana a Firenze fra Tre e Quattrocento, in Gabriella ROSSETTI (ed.), Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI, Napoli, Liguori, 1989, pp. 257-278.
[15] FRANCESCHI, Oltre il “Tumulto”, op. cit., pp. 174-177.
[16] Ibídem, pp. 116-117; 130-131; 172-177; 270-272.
[17] ZANOBONI, Donne al lavoro nell’Italia e nell’Europa medievali, op. cit, pp. 57-58 dove viene trascritta anche la delibera.
[18] Per un quadro generale si rimanda a ZANOBONI, Donne al lavoro nell’Italia e nell’Europa medievali, op. cit.
[19] Maria Paola ZANOBONI,“Pro trafegando in exercitio seu arte veletarum: tipologia e produzione dei veli nella Milano del secondo Quattrocento”, in Maria Giuseppina MUZZARELLI, Maria Grazia NICO OTTAVIANI, Gabriella ZARRI (eds), Il velo in area mediterranea fra storia e simbolo. Tardo Medioevo- prima Età moderna, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 123-138.
[20] ZANOBONI, Donne al lavoro nell’Italia e nell’Europa medievali, op. cit, pp. 86-90 e 101-107; EAD., “Pro trafegando”, op. cit.
[21] Paula CLARKE, Le “mercantesse” di Venezia nei secoli xiv e xv, in Anna BELLAVITIS e Linda GUZZETTI (eds.), Donne, lavoro, economia a Venezia e in Terraferma tra medioevo ed età moderna, fascicolo monografico di Archivio Veneto, serie VI, fasc. 3, 2012, pp. 67-84.
[22] Su Genova Denise BEZZINA, Donne artigiane e famiglie nella Genova medievale (secc. xii-xiii): una rivisitazione del paradigma di Diane Owen Hughes, relazione tenuta al VI Congresso della Società Italiana delle Storiche, Padova, 14 febbraio 2013; Ead., Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII, Firenze, Retimedievali-Firenze University Press, 2015, pp. 67-71.
[23] Luigi BRENNI, L’arte del battiloro e i filati d’oro e d’argento, Milano, 1930, pp. 35-42 e pp. 39-41 in particolare.
[24] BRENNI, L’arte del battiloro, op. cit., p. 39.
[25] Geo PISTARINO, Le donne d'affari a Genova nel sec. xiii, in Miscellanea di storia italiana e mediterranea per N. Lamboglia, Genova, 1978, pp. 157-179, pp. 164-165 e p. 168.
[26] Ignazio DEL PUNTA, Lucca e il commercio della seta nel Medioevo, Pisa, Pacini, 2010, pp. 135-141, p. 149, p. 155; Ignazio DEL PUNTA, Maria Ludovica ROSATI, Lucca una città di seta. Produzione, commercio e diffusione dei tessuti lucchesi nel tardo Medioevo, Lucca, Pacini Fazzi, 2018.
[27] Florence EDLER DE ROOVER, L’arte della seta a Firenze nei secoli xiv e xv, Sergio TORNETTI (ed.), Firenze, Olschki, 1999, pp. 51-56.
[28] Al lavoro delle donne veneziane nel tardo Medioevo e nell’età moderna, è stato recentemente dedicato un fascicolo monografico della rivista Archivio Veneto: Donne, lavoro, economia a Venezia e in Terraferma tra medioevo ed età moderna, a cura di Anna BELLAVITIS e Linda GUZZETTI, Archivio Veneto, serie VI, fasc. 3, 2012.
[29] Luca MOLÀ, “Le donne nell’industria serica veneziana del Rinascimento”, in La seta in Italia dal Medioevo al Seicento. Dal baco al drappo, Atti del Convegno, Venezia, Marsilio, 2000, pp. 423-459, p. 427, pp. 437-440, e p. 444.
[30] CLARKE, Le “mercantesse” di Venezia nei secoli xiv e xv, op.cit, pp. 67-84; EAD., Donne nel commercio e nella produzione nel tardo Medioevo: il caso delle mercantesse di Venezia, in Paola AVALLONE e Gemma Teresa COLESANTI (eds.), Donne e lavoro: attività, ruoli, complementarietà. Secc.xiv-xix. Atti del III Seminario di Studi Dottorali di Storia ed economia nei paesi del Mediterraneo (Napoli, 3-7 ottobre 2016), Cagliari, CNR-Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, 2019, pp. 193-216.
[31] CLARKE, Le “mercantesse” di Venezia, op. cit.
[32] Ibídem.
[33] Ibídem.
[34] Edoardo DEMO, “Donne imprenditrici nella Terraferma Veneta della prima età moderna (secoli xv-xvi)”, Archivio Veneto, CXLIII (2012), fasc.2, pp. 85-95.
[35] Ibídem.
[36] La manifattura serica ebbe origine a Milano, quando, verso la metà del ‘400, vi si stabilirono, attirate dalla promessa di sgravi fiscali, maestranze toscane, genovesi, veneziane, bergamasche e spagnole, che costituirono un primo piccolo nucleo di tessitori-imprenditori destinati a folgoranti carriere grazie all’associazione e ai finanziamenti del ceto nobiliare-mercantile milanese, che in un secondo momento prese in mano direttamente tutto il processo produttivo. Cfr. Maria Paola ZANOBONI, Artigiani, imprenditori, mercanti. Organizzazione del lavoro e conflitti sociali nella Milano sforzesca (1450-1476), Firenze, La Nuova Italia, 1996; EAD, “I Da Gerenzano “ricamatori ducali” alla corte sforzesca”, Storia Economica, VII (2004), fasc. II, pp. 496-545; EAD., “Battiloro e imprenditori auroserici: mobilità sociale e forniture di corte nella Milano quattrocentesca (prima parte)”, Storia Economica, XIII (2010), fasc.1-2, pp.147-186, e seconda parte, ivi, XIII (2010), fasc.3, pp. 345-374. Sull’argomento cfr. anche Paolo GRILLO, “Le origini della manifattura serica a Milano (1400-1450)”, Studi Storici, 35 (1994), pp. 897-916; Patrizia MAINONI, “La seta a Milano nel xv secolo: aspetti economici e istituzionali”, Studi Storici, 35 (1994), pp. 871-896.
[37] Per una panoramica completa cfr. ZANOBONI, Donne al lavoro nell’Italia e nell’Europa medievali, op. cit., pp. 80-86.
[38] Su trattura, incannatura e binatura: Carlo PONI, “All’origine del sistema di fabbrica: tecnologia e organizzazione produttiva dei mulini da seta nell’Italia settentrionale (Secc.xvii /xviii)”, Rivista Storica Italiana, LXXXVIII (1976), pp. 444-497; ID., “Misura contro misura: come il filo di seta divenne sottile e rotondo”, Quaderni Storici, XVI (1981), pp. 959-1011; Angela GROPPI (ed.), “Tecnologie, organizzazione produttiva e divisione sessuale del lavoro: il caso dei mulini da seta”, in Il lavoro delle donne, Roma-Bari, 1996, pp. 269-298.
[39] Gli statuti del 1479 sono stati pubblicati in: ZANOBONI, Artigiani, imprenditori, mercanti, op. cit., pp. 231-234, a cui si rimanda anche per i rapporti tra i filatori e le donne in quell’epoca. Su quelli del 1511: Maria Paola ZANOBONI, “Gli statuti del 1511 dei filatori di seta milanesi”, Archivio Storico Lombardo, CXX (1994), pp. 423-444. Sull’argomento anche Maria Paola ZANOBONI, “Noctis tempore rapuit et exportavit rotam. Disavventure dell’unico mulino da seta ad energia idraulica di Milano (seconda metà del secolo xv)”, Storia Economica, a. IV (2001), n. 1, pp. 149-183, anche in EAD. Rinascimento sforzesco.
[40] ZANOBONI, Gli statuti del 1511 dei filatori di seta milanesi, op. cit., pp. 423-444.
[41] Statuti 1479, pubblicati in ZANOBONI, Artigiani, op. cit., pp. 231-234.
[42] Statuti 1511, pubblicati in ZANOBONI, Gli statuti del 1511, op. cit.
[43] Statuti 1511. La perquisizione poteva avvenire “nonostante gli ordini dei mercanti”, che invece appoggiavano le donne a scapito dei filatori.
[44] “Insultati et gravibus vulneribus percussi et quasi semimortui derelicti”: Paola MASSA, L’arte genovese della seta nella normativa del xv e del xvi secolo, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 1970, pp. 176-177 e pp. 268-269 (appendice, doc. 20), riportato Franco FRANCESCHI, L. MOLÀ, Discriminazione, sopraffazione, violenza nel mondo del lavoro, in Anna ESPOSITO, Franco FRANCESCHI, Gabriella PICCINNI (eds.), Violenza alle donne. Una prospettiva medievale, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 57-84, p. 70.
[45] Ibídem.
[46] Luca MOLÀ, Le delazioni nel mondo dell’industria veneziana, in Riferire all’autorità. Denuncia e delazione tra medioevo ed età moderna, Roma, Viella, 2020, pp. 141-158: pp. 149-150.
[47] MOLÀ, “Le donne nell’industria serica veneziana”, op. cit, p. 427, pp. 437-440, e p. 444. Cfr. Anche più sopra.
[48] Maria Paola ZANOBONI, “Quod dicti denarii non stent mortui. Lavoro e imprenditoria femminile a Milano tra Quattro e Cinquecento”, Archivio Storico Italiano, CXXV (2007), fasc. IV, n. 614, pp. 699-735: p. 714.
[49]Sulle tessitrici di veli di Basilea: Catherine C. SIMON-MUSCHEID, “La lutte des maìtres tisserands contre les tisserandes à Bàle. La condition féminine au xve siècle”, in Simonetta CAVACIOCCHI (ed.), La donna nell’economia (secc.xiii-xviii). Atti della XXI Settimana di Studio dell'Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini (aprile 1989), Firenze, Le Monnier, 1990, pp. 383-389.
[50] Gli statuti dei tessitori lucchesi sono pubblicati in Girolamo TOMMASI, “Sommario della storia di Lucca”, presentazione di Domenico Corsi, Lucca, Maria Pacini Fazzi Editore, 1969 [rist. anast. dell’ed. di Firenze del 1847], Documenti, serie seconda, XXXII, pp. 66-87. Per una sintesi: Franco FRANCESCHI, ¿“Un paradiso delle “lavorantesse”? Le donne nello statuto della corporazione dei tessitori di seta lucchesi (1482-83)”, in Roberta MUCCIARELLI e Michele PELLEGRINI (eds.), Il tarlo dello storico, op. cit., pp. 291-308.
[51] Maria Paola ZANOBONI, “‘De suo labore et mercede me adiuvavit’. La manodopera femminile a Milano nell’età sforzesca”, Nuova Rivista Storica, LXXVIII (1994), pp. 103-122, e in EAD, Produzioni, commerci, lavoro femminile nella Milano del xv secolo, Milano, CUEM, 1997. Sui battiloro a Milano: ZANOBONI, Battiloro e imprenditori (prima parte), op. cit, pp. 147-186, e seconda parte, pp. 345-374; EAD., “L’inventario dei beni di Pietro da Colonia, battiloro a Milano (1476)”, Archivio Storico Italiano, CLXXIII (2015), fasc. IV, n.645, pp. 661-686. Sull’argomento anche: Paola CURATOLO, “Apprendistato e organizzazione del lavoro nell’industria auroserica milanese (xvi-xvii secolo)”, in Elena BRAMBILLA e Giovanni MUTO (eds.), La Lombardia spagnola: nuovi indirizzi di ricerca, Milano, UNICOPLI, 1997, pp. 91-109.
[52] ZANOBONI, Artigiani, imprenditori, mercanti, op. cit, pp. 130-142; ZANOBONI, Donne al lavoro nell’Italia e nell’Europa medievali, op. cit.
[53] Intorno al 1452, quasi contemporaneamente alla manifattura serica, due setaioli milanesi riuscirono ad avviare nella capitale del ducato sforzesco, grazie a maestranze genovesi e tedesche, anche la produzione della foglia d’oro da filare, indispensabile al ricamo e alla tessitura dei drappi auroserici (ZANOBONI, Artigiani, imprenditori, mercanti, op. cit., pp. 130-142).
[54] Ibídem.
[55] ZANOBONI, “De suo labore”, op. cit; Ead., Artigiani, imprenditori, mercanti, op. cit., pp. 130-145.
[56] M. WENSKY, “Discussione”, in Simonetta CAVACIOCCHI (ed.), La donna nell’economia (secc. xiii-xviii). Atti della XXI Settimana di Studi dell’Istituto Internazionale di Storia economica “F. Datini” [aprile 1989], Firenze, Le Monnier, 1990, pp. 137-142.
[57] Bruno DINI, “Una manifattura di battiloro nel Quattrocento”, in Saggi su un’economia-mondo, Pisa, 1995, pp. 87-115; Id., I battilori fiorentini nel Quattrocento, in Manifattura, commercio e banca nella Firenze medievale, Firenze, Nardini, 2001, pp. 45-64.
[58] Maria Paola ZANOBONI, Battiloro e imprenditori auroserici, parte prima, op. cit, pp. 147-186 e parte seconda, pp. 345-374; Sergio TOGNETTI, I Gondi di Lione. Una banca d’affari fiorentina nella Francia del primo Cinquecento, Firenze, Olschki, 2013.
[59] ZANOBONI, Battiloro e imprenditori auroserici, op. cit.
[60] ZANOBONI, “I Da Gerenzano “ricamatori ducali””, op. cit.; Ead., Battiloro e imprenditori auroserici, op. cit., e la bibliografia ivi citata.
[61] Per una sintesi sulla produzione dei veli in Italia e in Europa e per la relativa bibliografia: ZANOBONI, Donne al lavoro nell’Italia e nell’Europa medievali, op. cit., pp. 86-91.
[62] Per avere un’idea degli articoli prodotti si veda l’inventario pubblicato in Maria Paola ZANOBONI, “Cuffie, veli e gorgiere in un inventario milanese d’inizio Cinquecento”, Storia Economica, XXIV (2021), fasc. 1-2, pp. 13-44. Sull’argomento anche: Rosita LEVI PISETZKY, Storia del costume in Italia, Fondazione Treccani, vol. II, Milano, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1964, pp. 118-133 e pp. 287-299 (con ricca iconografia); EAD, Il costume e la moda nella società italiana, Torino, Einaudi, 1978, pp. 149-150; p. 169; pp. 189-191; Maria Giuseppina MUZZARELLI, A capo coperto. Storie di donne e di veli, Bologna, Il Mulino, 2016; Virtus ZALLOT, Sulle teste nel Medioevo: storie e immagini di capelli, Bologna, Il Mulino, 2021.
[63] Maria Paola ZANOBONI, “Milano 1481. Due donne imprenditrici”, Nuova Rivista Storica, LXXXI (1997), pp. 159-168, e in EAD., Produzioni, commerci, lavoro femminile nella Milano del xv secolo, Milano, CUEM, 1997; EAD., “Pro trafegando in exercitio seu arte veletarum”, op. cit., pp. 123-138.
[64] Maria Paola ZANOBONI, “I Da Gerenzano ‘ricamatori ducali’”, op. cit.; EAD, “Pro trafegando”, op. cit. Per la tipologia di cuffie confezionate da Orsina, si rimanda al citato inventario (1506) della bottega del figlio, G. Giacomo da Sesto, mercante e imprenditore di veli, cuffie e gorgiere, pubblicato in ZANOBONI, Cuffie, veli e gorgiere, op. cit.
[65] In entrambi i suoi testamenti (1498 e 1500) il ricamatore Antonio da Sesto, marito di Orsina, dichiarava uno svariato numero di crediti verso la corte sforzesca, per un totale di oltre £.10.000, che, a quasi 10 anni di distanza, non era ancora riuscito a riscuotere. Non volendo assolutamente rinunciare a quella somma, esortava perciò i figli in modo accorato ad esigere il denaro al più presto. Sull’argomento ZANOBONI, Rinascimento sforzesco, op. cit., pp. 23-86.
[66] Cfr anche più oltre.
[67] ZANOBONI, Cuffie, veli e gorgiere, op. cit.
[68] Sulla filatura dell’oro a Milano: ZANOBONI, “De suo labore”, op.cit. Il timore dei furti di materia prima in questo settore era tale che i mercanti fiorentini (seconda metà sec.xv) distribuivano la foglia d’oro da filare soltanto ai conventi. In quello del Gaggio, all’inizio del ‘500, fu anzi creata un’apposita “sala dell’oro” a cui avevano accesso soltanto le monache altolocate, le uniche a cui era consentito esercitare l’attività. In modo analogo a Venezia, le “mercantesse pubbliche” di oro filato, che dalla metà del ‘300 controllavano l’intero ciclo produttivo, erano obbligate ad iscriversi ad un albo e a versare una cauzione per poter esercitare. Cfr. Bruno DINI, Una manifattura di battiloro nel Quattrocento, in ID. (ed.), Saggi su un’economia-mondo, Pisa, 1995, pp. 87-115: pp. 108-109; CLARKE, Le “mercantesse” di Venezia, op. cit., pp. 67-84; Sharon T. STROCCHIA, Nuns and Nunneries in Early Modern Florence, John Hopkins University Press, Baltimore and London, 2009, pp. 124-128.
[69] ZANOBONI, “Pro trafegando in exercitio seu arte veletarum”, op. cit., pp. 131-132.
[70] MOLÀ, “Le donne nell’industria serica veneziana”, op. cit., pp. 437-438.
[71] Come dimostra in modo eloquente una società per la produzione e la vendita al dettaglio di tessuti di lana costituita il 24 maggio 1453, in cui i ¾ dell’ingentissimo capitale (15.000 lire su 20.630) era conferito da due sorelle e dall’erede della terza. L’accordo societario fu rinnovato più volte, con una durata complessiva di oltre 30 anni, sciogliendosi solo nel febbraio del 1485 (ZANOBONI, “Quod dicti denarii”, doc. n. 1). Sugli sviluppi della manifattura laniera a Milano nel secondo ‘400: Maria Paola ZANOBONI, “Lana, berretti e mercanti inglesi nella Milano sforzesca”, Storia Economica, XXII (2019), fasc. 1, pp. 6-67.
[72] ZANOBONI, “Quod dicti denarii”, op. cit., pp. 714-715.
[73] Ibídem, pp. 715-716.
[74] ARCHIVIO DI STATO DI MILANO (d’ora innanzi ASMi), Notarile, cart. 3883, atto n. 421, 1485 febbraio; atto n. 433, 1485 agosto 19.
[75] ASMi, Notarile, cart. 4495, 1501 ottobre 22. Si trattava di Lucrezia Landriani q. Antonio, vedova di Ottone Visconti, apparteneva a un’importante famiglia di funzionari ducali. Un Antonio Landriani (ma non parrebbe il padre di Lucrezia) fu banchiere, appaltatore di dazi e tesoriere generale del Ducato di Milano nel 1474. Cfr. Nadia COVINI, Landriani, Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, Fondazione Treccani, vol. 63, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004. Sui da Gerenzano: ZANOBONI, “I Da Gerenzano ‘ricamatori ducali’”, op. cit.
[76] Per le donne medico, in Italia e in Europa, si rimanda invece a ZANOBONI, Donne al lavoro nell’Italia e nell’Europa medievali, op. cit. Molte donne medico e chirurgo erano attive a Napoli e nel Meridione nel ‘300 (con licenza ufficiale di esercitare la professione ottenuta da Carlo d’Angiò), e a Roma nel ‘400: Anna ESPOSITO, “Le donne in ospedale nell’Italia centro- settentrionale (fine xiv-inizio xvi secolo)”, in Gabriella PICCINNI (ed.), Alle origini del welfare. Radici medievali e moderne della cultura europea dell’assistenza, Roma, Viella, pp. 427-446; Gemma Teresa COLESANTI, Daniela SANTORO, Forme e spazi dell’assistenza femminile nella Corona d’Aragona (secoli xiv e xv), ivi, pp. 447-470, pp. 450-451.
[77] Sharon T. STROCCHIA, “The Nuns Apothecaries of Renaissance Florence: Marketing Medicines in the Convent”, Renaissance Studies, XXV (2011), fasc. 5, pp. 627-647; EAD., Nuns and Nunneries in Early Modern Florence, op. cit.
[78] ZANOBONI, Donne al lavoro nell’Italia e nell’Europa medievali, op. cit., pp. 119-120 e pp. 138-139.
[79] Su Caterina Sforza: Pier Desiderio PASOLINI, Caterina Sforza, Firenze, G. Barbera Editore, 1913; Aldo RANDI, Caterina Sforza, Milano, Ceschina, 1951; Ernst BREISACH, Caterina Sforza a Renaissance virago, Chicago, London University of Chicago Press, 1967; Natale GRAZIANI, Gabriella VENTURELLI, Caterina Sforza, Milano, Dall’Oglio Editore, 1987; Joyce DE VRIES, Caterina Sforza and the Art of Appearances: Gender, Art and Culture in Early Modern Italy, Farnham, Ashgate, 2010.
[80] Sul ricettario di Caterina: V. NIGRISOLI, Cenni sul ricettario di Caterina Sforza, “La Piè”, sett.-ott. 1928; ID., Spigolature dal ricettario di Caterina Sforza, “La Piè”, febb. 1928; Mario TABANELLI, Ricette di medicina dal libro degli Experimenti di Caterina Sforza, “La Piè”, 1970; F. DELITALA, Caterina Sforza e la cura della sciatica, in La chirurgia degli organi in movimento, vol. 60, fasc. 6, Bologna, Cappelli; Meredith K. RAY, Daughters of Alchemy. Women and Scientific Culture in Early Modern Italy, Cambridge, Harvard University Press, 2015; Silvio LOMBARDI, Lo speziale di Caterina Sforza, Roma, Vertigo, 2016; Paolo Aldo ROSSI, Experimenti de la Excellentissima Signora Caterina da Furlì, Castel Negrino, Aicurzio, 2018.
[81] RAY, Daughters of Alchemy, op. cit., pp. 18-19 e pp. 178-179; Anna LAGHI, “Cristoforo de Brugora speziale della duchessa Bona e della corte sforzesca”, in Atti del IX convegno culturale e professionale dei farmacisti dell’Alta Italia, Pavia, 1959, pp. 141-147.
[82] GRAZIANI, VENTURELLI, Caterina Sforza, op. cit., p. 76.
[83] ZANOBONI, “Quod dicti denarii”, op. cit., pp. 28-29 dove è pubblicato il regesto del documento, datato 21 agosto 1481.
[84] Ibídem, doc. n. 13. Nell’apprendistato vero l’insegnamento impartito dal maestro aveva un valore non indifferente, per cui era il docente ad essere retribuito, e non l’allievo. I contratti di apprendistato fasulli, invece, non erano finalizzati all’insegnamento ma all’assunzione di un garzone di bottega, che quindi percepiva un modesto compenso per il lavoro svolto. Cfr. in proposito Franco FRANCESCHI, La “grande” manifattura tessile, in La trasmissione dei saperi nel Medioevo (secoli xii-xv), Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte di Pistoia, 2005, pp. 355-389; ID., “I Giovani, l’apprendistato, il lavoro”, in I Giovani nel medioevo. Ideali e pratiche di vita, atti del convegno tenutosi ad Ascoli Piceno, 29 novembre-2 dicembre 2012, Ascoli Piceno, Capponi Editore, 2014.
[85] Il regesto del documento, datato 6 luglio 1524, è pubblicato in ZANOBONI, “Quod dicti denarii”, op. cit., pp. 36-37.
[86] Diane GHIRARDO, “Le bufale estensi e l’imprenditoria femminile ducale nella Ferrara del Rinascimento”, Ferrariae Decus. Studi in onore di Luciano Chiappin, 22 (2004), pp. 68-85; Ead., Le duchesse, le bufale e l’imprenditoria femminile nella Ferrara rinascimentale, Ferrara, Di Scaranari Editore, 2009.
[87] Diane GHIRARDO, “Lucrezia Borgia, imprenditrice nella Ferrara rinascimentale”, in Letizia Arcangeli e Susanna Peyronel (eds.), Donne di potere nel Rinascimento, Roma, Viella, 2008, pp. 129-143; Ead., “Lucrezia Borgia as entrepreneur”, Renaissance Quarterly, 61 (2008), pp. 53-91. Di Lucrezia è stato pubblicato l’inventario del guardaroba e dei gioielli: I tesori di Lucrezia Borgia d’Este: gli inventari del guardaroba (1502-1504) e delle gioie (1516-1519) nel fondo Archivio segreto estense dell'Archivio di Stato di Modena, edizione critica a cura di Diane GHIRARDO; con la collaborazione di Lorenza Iannacci e Francesca Speranza, Modena, Golinelli, 2019. Il suo epistolario completo, insieme al suddetto inventario e a tutti i suoi libri contabili, sono stati digitalizzati al sito: https://lodovico.medialibrary.it/media/ricercadl.aspx?keywords=lucrezia+borgia. Si veda inoltre: https://www.asmo.beniculturali.it/progetti/lucrezia-borgia-deste-celebrazioni-a-500-anni-dalla-morte.
[88] Ivana AIT, “I Margani e le miniere di allume di Tolfa: dinamiche familiari e interessi mercatili fra xiv e xvi secolo”, Archivio Storico Italiano, CLXVIII (2010), pp. 231-262, pp. 250-252; EAD, “Donne in affari: il caso di Roma (secoli xiv-xv)”, in Anna ESPOSITO (ed.), Donne del Rinascimento a Roma e dintorni, Roma, Fondazione Marco Besso, 2013, pp. 53-84, pp. 79-81; EAD, “Un’imprenditrice nella Roma del Rinascimento”, in Marco PALMA e Cinzia VISMARA (eds.), Per Gabriella. Studi in ricordo di Gabriella Braga, Edizioni Università di Cassino, Catanzaro 2013, pp. 9-26.
[89] Catherine KIKUCHI, “Les femmes dans le milieu du livre vénitien, fin duXVe-début XVIe siècle”, intervention proposée dans le cadre de la journée d’études du 22 mars 2014 organisée par Elisabeth CROUZET PAVAN, Acteurs sociaux en situations (Europe. Fin du Moyen Age), in www.academia.edu.
[90] Rosa Marisa BORRACINI, “All’ombra degli eredi: l’invisibilità femminile nelle professioni del libro. La fattispecie marchigiana”, in M. SANTORO (ed.), Le donne nel Rinascimento meridionale, atti del Convegno, Roma, 11-13 marzo 2009, Pisa-Roma, Fabrizio Sara Editore, 2010, pp. 413-428, p. 420, www.academia.edu; Philippe BRAUNSTEIN, Les Allemands à Venise (1380-1520), Rome, Ecole Française de Rome, 2016, pp. 740-741.
[91] BORRACINI, “All’ombra degli eredi”, op. cit., p. 420.
[92] ZANOBONI, “Quod dicti denarii”, op. cit., pp. 699-735.
[93] Anna ESPOSITO, “Perle e coralli: credito e investimenti delle donne a Roma (xv- inizio xvi secolo)”, in Dare credito alle donne, op. cit., pp. 231-233; AIT, Donne in affari, op. cit., pp. 76-77.
[94] ESPOSITO, “Perle e coralli”, op. cit., pp. 231-233; AIT, Interessi, solidarietà e crescita economica, op. cit., p. 107.
[95] Cristina PÉREZ GALÁN, “En torno al valor de las cosas pequeñas: la tasación, un trabajo de mujeres en la ciudad de Huesca en la Baja Edad Media”, in Concepción VILLANUEVA MORTE, Diego A. REINALDOS MIÑARRO, Jorge MAÍZ CHACÓN, Inés CALDERÓN MEDINA (eds.), Estudios recientes de jóvenes medievalistas. Lorca 2012, Murcia, Compobell, 2013, pp. 127-135, Mª del Carmen GARCÍA HERRERO, “El trabajo de las mujeres en la resoluciòn de conflictos: los arbitrajes femeninos en el Reino de Aragòn en la Baja Edad Media”, in Paola AVALLONE e Gemma Teresa COLESANTI (eds.), Donne e lavoro: attività, ruoli, complementarietà. Secc.xiv-xix, Atti del III Seminario di Studi Dottorali di Storia ed economia nei paesi del Mediterraneo (Napoli, 3-7 ottobre 2016), Cagliari, CNR-Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, 2019, pp. 19-41.
[96] Ivana AIT, “Interessi, solidarietà e crescita economica: il finanziamento delle attività produttive a Roma nel xv secolo”, in Mauro CARBONI e Maria Giuseppina MUZZARELLI (eds.), Reti di credito. Circuiti informali, impropri, nascosti (secoli xiii-xix), Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 91-108: pp. 98-105.
[97] Daniele LOMBARDI, “I mestieri della moda: sarti e calzolai nella Roma del Quattrocento”, in Ivana AIT, Daniele LOMBARDI, Anna MODIGLIANI (eds.), Forme e linguaggi dell’apparire nella Roma Rinascimentale, Roma, Roma nel Rinascimento, 2022, pp. 83-112: p. 99.
[98] Gabriella PICCINNI, Il banco dell’ospedale di Santa Maria della Scala e il mercato del denaro nella Siena del Trecento, Pisa, Pacini, 2012, pp. 196-201.
[99] Ivana AIT, Donatella STRANGIO, “‘Turisti per … ventura’. L’attività alberghiera a Roma nel Rinascimento”, in Storia del Turismo. Le imprese, Annale 8, Milano, F. Angeli, 2010, pp. 13-44: pp. 25-26 e pp. 29-30; ESPOSITO, Perle e coralli, op. cit.; AIT, Donne in affari, op. cit.
[100] ESPOSITO, Perle e coralli, op. cit., p. 229.
[101] AIT, Donne in affari, op. cit., pp. 68-69.
[102] Sul lavoro delle donne nell’edilizia in Italia e in Europa: ZANOBONI, Donne al lavoro nell’Italia e nell’Europa medievali, op. cit.
[103] Marina GAZZINI, “Vite femminili negli ospedali medievali: pregare, lavorare, lasciare memoria di sé (Italia centro-settentrionale)”, in Vita religiosa al femminile (secoli xiii-xiv), Atti del XXVI Convegno Internazionale di studi, Pistoia, 19-21 maggio 2017, Roma, Viella, 2019, pp. 91-105: pp. 98-99.
[104] Duccio BALESTRACCI, “‘Li lavoranti non cognosciuti’. Il salariato in una città medievale (Siena 1340-1344)”, Bullettino Senese di Storia Patria, LXXII-LXXXIII (1975-1976), pp. 127-182.
[105] Il documento è stato pubblicato in Maria Paola ZANOBONI, “Donne al lavoro nell’edilizia medievale”, Archivio Storico Italiano, CXXXII (2014), fasc. I, pp. 109-132.
[106] Cfr, ZANOBONI, Donne al lavoro nell’Italia e nell’Europa medievali, op. cit., pp. 91-100 e la bibliografia ivi citata.
[107] Maria Paola ZANOBONI, Donne al lavoro nell’edilizia medievale, op. cit.
[108] Nei cantieri delle chiese di Gerona durante il sec. xv, ad esempio: Sandrine VICTOR, “Bàtisseuses de cathédrales? Le travail des femmes dans le secteur de la construction au bas Moyen Age selon l’exemple de Gérone”, Mélanges de la Casa de Velázquez, 40-2 (2010), pp. 59-72: pp. 68-69.
[109] Della stessa opinione Andrea Caracausi, che, in base all’esame dei documenti, osserva appunto come non fosse il genere a determinare i salari, e che le donne erano retribuite meno quando rendevano meno, allo stesso modo se la resa era la stessa, e di più se rendevano di più o c’era maggior convenienza ad assumerle (Andrea CARACAUSI, Dentro la bottega. Culture del lavoro in una città d’età moderna, Venezia, Marsilio, 2008, p. 126; ID., “I giusti salari nelle manifatture della lana di Padova e Firenze (secoli xvi-xvii)”, Quaderni Storici, 135, XLV (2010), n. 3, dicembre, pp. 857-883: p. 871; Id., “The Price of an Apprentice: Contracts and Trials in the Woollen Industry in Sixteenth Century Italy”, MEFRIM (2016), p. 128-1, pp. 1-13, p. 6. L’idea che il genere non costituisse il fattore fondamentale nella determinazione dei salari era già stata espressa da G. Nigro nel 1989: Giampiero NIGRO, “Discussione”, in Simonetta CAVACIOCCHI (ed.), La donna nell'economia (secc.xiii-xviii). Atti della XXI Settimana di Studio dell'Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini (aprile 1989), Firenze, Le Monnier, 1990, p. 157.
[110] Luciana FRANGIONI, Aspettando Smeralda. Prime note sul lavoro delle donne fra Tre e Quattrocento, Ripalimosani, 1995 (Quaderni di Studi Storici-7- Università degli Studi del Molise), ora anche in Storia Economica, I (1998).
[111] Anna BELLAVITIS, “Apprendiste e maestre a Venezia tra Cinque e Seicento, in e in Terraferma tra medioevo ed età moderna”, a cura di Anna Bellavitis e Linda Guzzetti, fascicolo monografico di Archivio Veneto serie VI, fasc. 3, 2012, pp. 128-144, p. 139.
[112] A Genova nel 1201, a Prato nel 1321, a Oporto nel XV secolo: per i riferimenti puntuali cfr. ZANOBONI, Donne al lavoro nell’Italia e nell’Europa medievali, op. cit., cap. 7, pp. 143-144.
[113] ZANOBONI, “Quod dicti denarii”, op. cit., pp. 717-718; EAD, Donne al lavoro nell’Italia e nell’Europa medievali, op. cit., pp. 91-100.
[114] Irene GRAZIANI, Vera FORTUNATI, Properzia de’ Rossi. Una scultrice a Bologna nell’età di Carlo V, Bologna, Compositori, 2008.
[115] Consuelo LOLLOBRIGIDA, Plautilla Bricci. Pictura et architectura celebris. L’architettrice del barocco romano, Roma, Gangemi Editore, 2013.
[116] Antonio MACCHIONE, “Società di genere nella Calabria bassomedievale. Lavoro, professioni e rapporti economici (secc. xiv-xv)”, in Paola AVALLONE e Gemma Teresa COLESANTI (eds.), Donne e lavoro, op. cit., pp. 43-63, p. 54.
[117] Statuto del comune di Cortona (1325-1380), p. 239.
[118] Statuto del comune di Cortona (1325-1380), p. 498 e p. 404.
[119] ZANOBONI, “Quod dicti denarii”, op. cit., pp. 710-712.
[120] Ibídem, doc. n. 7, 1488 marzo 4.
[121] Ibídem.
[122] Per Vicenza: DEMO, “Donne imprenditrici nella Terraferma Veneta”, op. cit., p. 87. Per Treviso: Matthieu SCHERMAN, “I lavori delle donne nella Treviso del Quattrocento”, Genesis, VII, 1-2 (2008), pp. 233-245, pp. 244-245.
[123] Franco CIAPPI, Silvano MORI, “Beccuccio bicchieraio da Gambassi”.Competenze professionali e mobilità sociale nella Firenze rinascimentale, Pisa, Pacini, 2020, pp. 102-103.
[124] Isabelle CHABOT, “‘Breadwinners’. Familles florentines au travail dans le Catasto de 1427”, MEFRIM, 128-1 (2016), pp. 2-22, pp. 4-5.
[125] LOMBARDI, “I mestieri della moda: sarti e calzolai”, op. cit., pp. 93-94 e p. 106.
[126] Martina DEL POPOLO, “Il lavoro delle donne nella Siracusa del tardo quatrocento”, in Paola AVALLONE e Gemma Teresa COLESANTI (eds.), Donne e lavoro, op. cit., pp. 67-98, pp. 93-96.
[127] Valentina COSTANTINI, “Donne di carne: scorci femminili nel mondo dei carnaioli senesi (secoli xiii-xiv)”, in Roberta MUCCIARELLI e Michele PELLEGRINI (eds.), Il tarlo dello storico, op. cit., pp. 831-858, pp. 832-833.
[128] Beatrice DEL BO, L’età del lume. Una storia della luce nel Medioevo, Bologna, Il Mulino, 2023, pp. 203-206.
[129] Anna Maria NADA PATRONE, “La donna”, in Giosuè MUSCA (ed.), Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno Normanno-Svevo. Atti delle IX giornate Normanno-Sveve, Bari, 17-20 ottobre 1989, Edizioni Dedalo, Bari, 1991, pp. 103-130: pp. 128-129.
[130] Raffaele LICINIO, I luoghi della produzione artigianale, in Giosuè MUSCA (ed.), Centri di produzione della cultura nel Mezzogiorno Normanno-Svevo. Atti delle XII giornate normanno-sveve, Bari, 17-20 ottobre 1995, Edizioni Dedalo, Bari, 1997, pp. 327-353, p. 338.
[131] Patricia SKINNER, “Donne nel commercio amalfitano (secoli x-xii)”, in Giovanna CASAGRANDE (ed.), Donne tra Medioevo ed Età Moderna in Italia. Ricerche, Morlacchi Editore, 2004, pp. 3-22.
[132] Amedeo FENIELLO, Napoli. Società ed economia (902-1137), Roma, 2011, pp. 199-201; Gemma COLESANTI, Fiorella FRAGNOLI, “Operatrici economiche in Italia meridionale durante il Medioevo”, Mediterranean Chronicle, 4 (2014), pp. 57-73, pp. 59-60.
[133] COLESANTI, FRAGNOLI, “Operatrici economiche in Italia meridionale”, op. cit., p. 61.
[134] Ibídem, pp. 66-70.
[135] Ibídem, p. 72. Sull’argomento anche Gemma COLESANTI, “Il ruolo delle donne nelle attività commerciali del Mediterraneo tra xiv e xv secolo: ricerche in corso”, in Il dialogo dei saperi. Metodologie integrate per i beni culturali, IBAM – Consiglio Nazionale delle Ricerche, vol. II, Napoli 2010, pp. 905-919.
[136] Chiara FRUGONI (ed.), Il Villani illustrato. Firenze e l’Italia medievale nelle 253 immagini del manoscritto Chigiano L VIII 296 della Biblioteca Vaticana, Firenze, Le Lettere, 2005, pp. 168-169.
[137] Maria Rita LO FORTE SCIRPO, “La donna fuori casa: appunti per una ricerca”, Fardelliana, 4 (1985), pp. 85-95; Patricia SKINNER, Le donne nell’Italia medievale. Secoli vi-xiii, Roma, Viella, 2005, p. 221.
[138] Carmela Maria RUGOLO, “Donna e lavoro nella Sicilia del basso Medioevo”, in Donne e lavoro nell’Italia Medievale, pp. 67-82, pp. 71-72.
[139] LICINIO, I luoghi della produzione artigianale, op. cit., p. 338.
[140] RUGOLO, “Donna e lavoro”, op. cit., p. 78, nota 9, p. 80, nota 29, p. 81, nota 44.
[141] Ibídem, p. 79, nota 10.
[142] Gemma Teresa COLESANTI, Una mujer de negocios catalana en la Sicilia del siglo xv: Caterina Llull i Sabastida. Estudio y edición de su libro maestro 1472-1479, Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Institució Milà i Fontanals – Departamento de Estudios Medievales, Barcelona, 2008; EAD, “I libri di contabilità di Caterina Llull i Sabastida (xv sec.)”, Genesis, IX, 1 (2010), pp. 135-160. Sulle attività femminili a Siracusa nel xv secolo: DEL POPOLO, Il lavoro delle donne nella Siracusa del tardo quatrocento, op. cit.
[143] RUGOLO, “Donna e lavoro”, op. cit., p. 72, p. 79.
[144] Ibídem, p. 81, nota 35. Sulla Sicilia, per il xiii secolo, anche SKINNER, Le donne nell’Italia medievale, op. cit., pp. 220-221.
[145] RUGOLO, “Donna e lavoro”, op. cit., pp. 75-76.
[146] Barbara FOIS, Il lavoro femminile nei condaghi sardi dell’età giudicale (secc. xi-xiii), in Donne e lavoro nell’Italia Medievale, op. cit., pp. 55-66: p. 56 e pp. 60-61.
[147] Sulla disabilità in epoca medievale sono apparsi recentemente numerosi studi, per i quali si rimanda a ZANOBONI, Povertà femminile nel medioevo, op. cit., pp. 56-57, nota 80.
[148] Maria Teresa BROLIS, Storie di donne nel medioevo, Bologna, Il Mulino, 2017, p. 98.
[149] CHABOT, “Breadwinners”, op. cit., p. 10.
[150] Giovanni CHERUBINI, Gente del medioevo, Firenze, Le lettere, 1995, p. 55.
[151] Il problema dell’assistenza e dell’aiuto reciproco doveva essere molto sentito tra i non vedenti, la cui unica risorsa era la mendicità, tanto che in molte città italiane ed europee, dal ‘200 in poi, andarono costituendosi apposite compagnie di ciechi, dotate di guide e finalizzate all’aiuto reciproco. Sull’argomento e relativa bibliografia cfr. si rimanda a ZANOBONI, Povertà femminile nel medioevo, op. cit., pp. 57-58, nota 84.
[152] CHERUBINI, Gente del medioevo, p. 31. Giovanni Cherubini è stato tra i primi (e sicuramente il primo tra i pochissimi studiosi italiani) a mettere in evidenza l’importanza delle fonti agiografiche per la conoscenza degli aspetti più reconditi della vita quotidiana, con risultati eccezionali, difficilmente rintracciabili in documentazione di altro tipo.
[153] PAZTOR, “Esperienze di povertà al femminile”, in La conversione alla povertà nell’Italia dei secoli xii-xiv. Atti del XXVII Convegno Storico Internazionale (Todi 14-17 ottobre 1990), Spoleto, Centro di Studi sulla Spiritualità Medievale dell’Università degli Studi di Perugia, 1991, pp. 369-389: p. 382. La narrazione della vita di Sibillina, morta il 19 marzo 1367 a 79 anni, 64 dei quali trascorsi nel convento domenicano pavese di S. Tommaso, che l’aveva accolta dopo un periodo di mendicità, è contenuta in Acta Sanctorum, Martii, tomo III, apud Iacobum Meursium, 1668, pp. 67-71 “ … cum doleret quod visum amiserat, ex ea solummodo causa dolebat, quia victum sibi acquirere non poterat propriis laborando manibus, ut optabat: quod filando tentaverat, sed inde vivere non poterat quia filum caecitate a nimis ineptum tenebat” (Ibídem, p. 68).
[154] Cfr. ZANOBONI, Donne al lavoro nell’Italia e nell’Europa medievali, op. cit., pp. 112-122 e pp. 112-113.
[155] Bernardino RAMAZZINI, Le malattie dei lavoratori (De morbis artificum diatriba), a cura di Francesco CARNEVALI, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1982, pp. 167-169 [cap. XXXVII: Le malattie di coloro che fabbricano oggetti molto piccoli]. Sull’opera del Ramazzini cfr. il recente volume Giorgio COSMACINI, Storia della medicina del lavoro: da Bernardino Ramazzini a Salvatore Maugeri, Torino, UTET, 2022.
[156] E così continuava: “Tuttavia sarebbe utile, oltre l’uso degli occhiali, che questi operai non stessero sempre applicati al lavoro con la testa bassa, ma che di quando in quando togliessero le mani dal banco e volgessero gli occhi altrove, rubando qualche ora al loro lavoro, per distrarli e ricrearli guardando anche altri oggetti. Infatti, non si crederà mai abbastanza quanto giovi, a conservare intatta e sana la mobilità delle membrane degli occhi e la fluidità naturale degli umori, guardare vari e differenti oggetti da vicino, da lontano, in linea diretta, obliqua, e in qualsiasi altro modo; così infatti si conservano le capacità naturali dell’occhio, perché la pupilla ora si restringe, ora si dilata e l’umore cristallino, secondo i casi, ora si accosta alla pupilla, ora se ne allontana quando si guardano gli oggetti da lontano o da vicino. Altrimenti capita all’occhio la stessa cosa che succede agli altri organi: quando vengono trattenuti a lungo nella stessa posizione s’irrigidiscono e diventano incapaci di muoversi come prima …” (Ibídem, pp. 168-169). Altri brani di queste considerazioni del Ramazzini sono riportati in ZANOBONI, Donne al lavoro nell’Italia e nell’Europa medievali, op. cit., pp. 112-113.
[157] Sull’argomento Letizia PELLEGRINI, “La deformità fisica nelle fonti agiografiche del basso Medioevo”, in Gian Maria VARANINI (ed.), Deformità fisica e identità della persona tra medioevo ed età moderna. Atti del XIV Convegno di Studi organizzato dal Centro di Studi sulla civiltà del tardo medioevo, San Miniato (21-23 settembre 2012), Firenze, Firenze University Press, 2015, pp. 391-414: pp. 410-412.
[158] Molte donne cieche e sole, sui 40-50 anni, che riuscivano a sopravvivere soltanto chiedendo l’elemosina, sono documentate a Firenze nel ‘600 nei registri dell’ospedale dei mendicanti (Daniele LOMBARDI, Povertà maschile, povertà femminile. L’ospedale dei mendicanti nella Firenze dei Medici, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 81).
[159] P. A. SIGAL, Pauvreté et charité aux XIe et XIIe siècles d’après quelques textes hagiographiques, in études sur l’histoire de la pauvreté, vol. I, pp. 141-162: pp. 143-145; 149-150.
[160] PAZTOR, “Esperienze di povertà al femminile”, op. cit., pp. 369-389: p. 383. La vita di Margherita da Città di Castello è narrata in Acta Sanctorum, aprilis, tomo II, pp. 189-198. Per la bibliografia in proposito cfr. ZANOBONI, Povertà femminile nel medioevo, op. cit.
[161] Sull’atteggiamento tutt’altro che protettivo della famiglia verso anziani e disabili si rimanda a ZANOBONI, Povertà femminile nel medioevo, op. cit, e la bibliografia ivi citata.
[162] Ibídem.
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2023 Cuadernos Medievales

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.